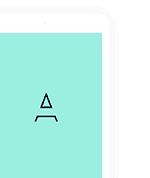Transcript
Ernesto De Martino: 'crisi della presenza' e 'apocalissi culturali'
INDICE
-Introduzione …............... …........................... ........................ ......................... ......................... ........................ .................p.5 .....p.5 I. LA CRISI DELLA PRESENZA NEL MONDO MAGICO… MAGICO ….p.8
1.1 Sul filo della presenza………………………………………….. presenza…………………………………………... p.8 .p.8 1.2 Perdere l’anima, perdere il mondo……………………………… mondo……………………………… p.10 1.3 La crisi della presenza…………………………………… presenza…………………………………………... ……... p.10 p.10 1.4 I momenti critici del divenire…………………………………… divenire…………………………………… p.12 1.5 Polo della crisi e polo del riscatto………………………………. riscatto………………………………. p.13 p.13 1.6 La magia come tecnica della presenza………………………….. presenza………………………….. p.14 p.14 1.7 Il “Cristo magico”: lo magico”: lo sciamano………………………………… sciamano………………………………… p.16 1.8 Istituti storici della magia: fattura e imitazione…………………. imitazione…………………. p.17 p.17 1.9 Il valore culturale del dramma magico…………………………. magico…………………………..p.19 .p.19 1.10 Le realtà del mondo magico…………………………………… magico…………………………………… p.20 1.11 La critica al soggetto trascendentale kantiano…………………. kantiano…………………. p.22 p.22 1.12 Del magico si può, si deve, fare storia…………………………. storia …………………………. p.25 p.25 1.13 Dasein e Dasein-sollen: un confronto con Heidegger …………. …………. p.26 p.26 1.14 Il rischio antropologico permanente………….……………... permanente………….……………...…. …. p.27 p.27
II. APOCALISSI CULTURALI………………………………….. CULTURALI…………………………………...p.29 .p.29
2.1 Magia e religione………………………………………………… religione………………………………………………… p.29 2.2 La ierogenesi come tecnica………………………………………. tecnica………………………………………. p.30 p.30 2.3 La destorificazione religiosa…………………………………….. religiosa……………………………………...p.31 .p.31 2.4 Il simbolismo simbolismo mitico-rituale……………………………………… mitico-rituale ……………………………………… p.33 2
2.5 L’eterno ritorno nella cultura…………………………………… cultura……………………………………..p.34 ..p.34 2.6 La fine del mondo………………………………………………... mondo………………………………………………... p.35 p.35 2.7 Il rituale del Mundus……………………………………………. ……………………………………………...p.36 ..p.36 2.8 L’ultimo giorno è sempre all’ordine del giorno………………….p.37 giorno………………….p.37 2.9 L’apocalittica cristiana………………………… cristiana………………………………………. ……………...….p.37 ..….p.37 2.10 L’eucarestia……………………………………………………... p.39 p.39 2.11 Apocalisse culturale…………………………………………….. culturale…………………………………………….. p.40 p.40 2.12 Immagini di apocalissi culturali………………………………... culturali………………………………....p.42 .p.42 2.13 L’apocalisse dell’Occidente………… d ell’Occidente…………………………… ………………………..…p.43 ……..…p.43 2.14 L’apocalisse nell’arte contemporanea…………………………...p.45 contemporanea…………………………...p.45 2.15 Il pensiero della fine…………………………………………….. fine…………………………………………….. p.45 p.45 2.16 L’apocalisse senza escaton……………………………………… p.47 2.17 Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche: confrontare per differenziare…………………………………………………. differenziare…………………………………………………. p.48 p.48 2.18 La fine del mondo come esperienza psicopatologica………...…. psicopatologica………...…. p.49 p.49 2.19 La crisi della presenza nella psicopatologia: derealizzazione e depersonalizzazione…………………………………………… depersonalizzazione…………………………………………… p.50 2.20 Catatonia e destorificazione irrelativa…………………………... irrelativa…………………………... p.51 p.51 2.21 Schizofrenia e mentalità primitiva……………………………… primitiva……………………………… p.53
III. LE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE DELLA CRISI DELLA PRESENZA…………………………………………… PRESENZA…………………………………………… p.55
3.1 Afasia della contiguità……………………………………………. contiguità……………………………………………. p.56 p.56 3.2 Afasia della similarità……………………………………………. similarità……………………………………………..p.57 .p.57 3.3 Linguaggio e crisi della presenza nella schizofrenia……………... schizofrenia……………... p.58 p.58 3.4 Il deragliamento linguistico………………………………………. linguistico………………………………………. p.59 p.59 3.5 Le parole come cose……………………………………………… cose……………………………………………… p.60 3
2.5 L’eterno ritorno nella cultura…………………………………… cultura……………………………………..p.34 ..p.34 2.6 La fine del mondo………………………………………………... mondo………………………………………………... p.35 p.35 2.7 Il rituale del Mundus……………………………………………. ……………………………………………...p.36 ..p.36 2.8 L’ultimo giorno è sempre all’ordine del giorno………………….p.37 giorno………………….p.37 2.9 L’apocalittica cristiana………………………… cristiana………………………………………. ……………...….p.37 ..….p.37 2.10 L’eucarestia……………………………………………………... p.39 p.39 2.11 Apocalisse culturale…………………………………………….. culturale…………………………………………….. p.40 p.40 2.12 Immagini di apocalissi culturali………………………………... culturali………………………………....p.42 .p.42 2.13 L’apocalisse dell’Occidente………… d ell’Occidente…………………………… ………………………..…p.43 ……..…p.43 2.14 L’apocalisse nell’arte contemporanea…………………………...p.45 contemporanea…………………………...p.45 2.15 Il pensiero della fine…………………………………………….. fine…………………………………………….. p.45 p.45 2.16 L’apocalisse senza escaton……………………………………… p.47 2.17 Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche: confrontare per differenziare…………………………………………………. differenziare…………………………………………………. p.48 p.48 2.18 La fine del mondo come esperienza psicopatologica………...…. psicopatologica………...…. p.49 p.49 2.19 La crisi della presenza nella psicopatologia: derealizzazione e depersonalizzazione…………………………………………… depersonalizzazione…………………………………………… p.50 2.20 Catatonia e destorificazione irrelativa…………………………... irrelativa…………………………... p.51 p.51 2.21 Schizofrenia e mentalità primitiva……………………………… primitiva……………………………… p.53
III. LE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE DELLA CRISI DELLA PRESENZA…………………………………………… PRESENZA…………………………………………… p.55
3.1 Afasia della contiguità……………………………………………. contiguità……………………………………………. p.56 p.56 3.2 Afasia della similarità……………………………………………. similarità……………………………………………..p.57 .p.57 3.3 Linguaggio e crisi della presenza nella schizofrenia……………... schizofrenia……………... p.58 p.58 3.4 Il deragliamento linguistico………………………………………. linguistico………………………………………. p.59 p.59 3.5 Le parole come cose……………………………………………… cose……………………………………………… p.60 3
3.6 Devianza semantica e neologismi………………………………… neologismi………………………………… p.61 3.7 Dissociazione semantica…………………………………………. semantica…………………………………………..p.63 .p.63 3.8 Linguaggio e presenza……………………………………………. presenza……………………………………………. p.64 p.64 3.9 Wahnstimmung e intenzioni di significato………………………... significato………………………... p.65 p.65 3.10 Eccesso e difetto di semanticità…………………………………. semanticità…………………………………. p.67 p.67 3.11 Troppo e troppo poco…………………………………………… poco…………………………………………….p.70 .p.70
- Bibliografia………………………………………………………….. Bibliografia…………………………………………………………...p.72 .p.72
4
Introduzione
La tematica che, con il presente lavoro, viene affrontata è quella della crisi della presenza, variamente illustrata negli scritti di Ernesto de Martino. L’intento non è tuttavia quello di dare un resoconto esaustivo del complesso ed elaborato itinerario demartiniano, né di ripercorrere le innumerevoli tappe del suo articolato percorso storico ed etnografico. Piuttosto che sulla sua attività di antropologo ci si soffermerà infatti su alcune specifiche questioni teoriche, dagli importanti risvolti filosofici, che, talora in superficie talora in modo carsico, percorrono tutta la sua produzione. Questi fils rouges, di cui possiamo rintracciare le origini fin dalle opere giovanili, sono i due nuclei concettuali di “crisi della presenza” e di “apocalisse culturale”. Il discorso sulla presenza, e sulla sua crisi, non potrà inoltre prescindere da una riflessione sul linguaggio, in quanto la natura umana si identifica e si caratterizza proprio per questa facoltà. Non si può mai cogliere l’uomo separato dal linguaggio; usando un’immagine di Saussure, presenza e linguaggio costituiscono il recto e il verso di un medesimo foglio. Nell’ultima parte del lavoro ci si occuperà dunque di filosofia del linguaggio; si mostrerà come la crisi della presenza, mettendo in discussione le caratteristiche salienti e le prerogative basilari dell’uomo, comporti necessariamente delle ripercussioni sul piano linguistico, piano per definizione appartenente all’ontologia e alla biologia umana. Nel primo capitolo la questione della crisi della presenza verrà illustrata nel particolare ambito del mondo magico, un mondo storico in cui la propria presenza individuale non è mai data per scontata, ma si configura piuttosto come un problema costante e una meta da conquistare. In questo speci fico frangente il “ci sono” è perennemente esposto al rischio di non esserci; l’individuo mette pertanto in atto varie strategie allo scopo di difendere la propria presenza e di mantenerla al cospetto del mondo. Le pratiche e i riti magici costituiscono la principale tecnica protettiva di cui si serve l ’uomo delle civiltà “primitive” per riscattare la propria presenza dalla crisi e dunque per poter agire nel mondo, piuttosto che lasciarsi agire da esso. 5
Nel secondo capitolo la nozione di apocalisse, concettualizzata da de Martino, ci permette di estendere la vicenda dell’oscillazione tra la crisi e la reintegrazione della presenza dal particolare all’universale. La ricerca verterà qui sui materiali raccolti all’interno dell’opera postuma di de Martino: La fine del mondo (1977). E’ sufficiente sfogliare l’indice di questa ricchissima e concett ualmente densa opera incompiuta per rendersi conto della varietà dei fenomeni cui il concetto di apocalisse fa riferimento. Il rischio di perdere la propria presenza e di “non esserci più nel mondo” si scopre non appartenere unicamente allo specifico orizzonte esistenziale del mondo magico, ma essere piuttosto un’ineludibile costante della condizione umana, un carattere distintivo dell’anthropos. La crisi della presenza si configura dunque come un carattere fisiologico dell’animale umano, come un rischio antropologico permanente che, trasferito su un piano simbolico e metaforico, si esprime nella paura per la fine del mondo. L’angoscia per il finire dell’or dine mondano esistente, -angoscia presente in tutte le epoche e in tutte le culture-, riproduce, su scala macroscopica, il perenne rischio della perdita della presenza. L’iterazione liturgica della fine e dell’inizio del mondo non fa che riproporre, in maniera metaforica e ritualizzata, la costante crisi e dunque la costante ripetizione del processo antropogenetico. Pur muovendo all’interno di una ricerca prevalentemente empirica i risultati dell’indagine demartiniana danno luogo a significative conseguenze sul piano filosofico, conseguenze ed implicazioni teoriche che in questa sede verranno messe in luce. Gli esiti della ricerca demartiniana reimpostano, affrontandoli da un inedito punto di vista, i più intricati problemi della tradizione speculativa moderna. De Martino muove infatti una radicale critica al soggetto trascendentale kantiano e all’essere -nel-mondo heideggeriano. La presenza non è un a- priori universalmente valido e garantito, un “sempre dato” che ci proviene dalla natura, ma costituisce piutt osto un punto d’arrivo reversibile, un approdo provvisorio e instabile. L’uomo deve costantemente rifondare la propria presenza nel mondo, deve regolarmente ripercorrere le tappe d ell’itinerario antropogenetico.
6
Anche l’atto linguistico è volto a fondare e a ricostituire la presenza umana nel mondo. Prima ancora di significare una qualsiasi cosa, l’enunciato si riferisce infatti al fatto che qualcuno lo ha prodotto, che qualcuno parla: ogni emissione di linguaggio segnala cioè
l’inserzione della presenza nel mondo. Linguaggio e presenza sono fenomeni corrispondenti e indissociabili. Nel terzo capitolo, partendo da questa imprescindibile identità, ci si occuperà della inevitabile coincidenza tra crisi della presenza e crisi dell’attività linguistica. Le manifestazioni linguistiche della crisi della presenza consistono essenzialmente in alterazioni di semanticità, in un dif etto o in un eccesso di questa. Il “troppo” e il “troppo poco” di semanticità, l’onniallusività del discorso e la regressione dal segno al segnale, costituiscono le reazioni linguistiche di una presenza che non riesce più a conferire un senso al mondo e dunque a se stessa nel mondo.
Il discorso sull’eccesso e sul difetto di semanticità verrà sviluppato aprendosi a differenti prospettive, seguendo più direzioni, non preliminarmente tracciate. Si esplorerà un terreno non ancora del tutto sondato, un angolo forse rimasto al buio, sicuramente meno argomentato da Ernesto de Martino, ma che pure egli solleva, consapevole della molteplicità degli sviluppi possibili, della pluralità delle direzioni che da qui potranno prendersi, dei plurimi luoghi, o forse non-luoghi, a cui potrà condurre.
7
I. LA CRISI DELLA PRESENZA NEL MONDO MAGICO
Il Mondo Magico (1948) è l’opera nella quale de Martino presenta la tematica che, come un fiume carsico, percorrerà tutta la sua futura produzione ed elaborazione teorica: quella della presenza e della crisi della presenza. Oltre i concetti, che saranno motivo di ulteriori approfondimenti e di feconde riflessioni nelle successive opere, sono qui presenti in nuce le loro profonde implicazioni, nonché le loro significative conseguenze, sul piano storico e filosofico. Il mio percorso prende dunque avvio dall’analisi di questa opera che costituisce la genesi, e allo stesso tempo già lascia scorgere i futuri sviluppi, del poliedrico pensiero demartiniano.
1.1 Sul filo della presenza
Nel mondo storico della magia la propria presenza individuale non è un fatto, un possesso garantito e saldo come nel nostro mondo culturale, ma una conquista temporanea, un’acquisizione precaria e fragile. L’unità stabil e della persona non si è ancora costituita ma è nell’atto del farsi. L’uomo tenta faticosamente di raccogliersi in se stesso, lottando contro forze contrarie e minacciose. La presenza è un soffio effimero che il mondo rischia, in ogni momento, di inghiottire e di vanificare. Essa viene “perduta”, “rapita”, “rubata”, “mangiata” e deve perciò essere di volta in volta “recuperata”, “ritrovata”, “fissata”. Ogni angolo dell’universo, ogni oggetto, ogni accadimento celano un’insidia per la presenza, costituiscono un pericolo radicale e rimandano all’angosciosa possibilità dell’impossibilità di esserci.
8
Nel mondo magico la presenza sta come una meta e un compito, come un dramma e un problema. Il “ci sono” è perennemente esposto al rischio di non esserci e la presenza, che non ha ancora la forza di “gettare davanti” a sé l’oggetto e di differenziarsene, rischia continuamente di smarrire la propria trascendenza, di perdere se stessa e di abdicare. In questa fase storica il confine tra uomo e natura, tra soggetto e oggetto deve ancora essere tracciato, e l’uomo è continuamente tentato ad “adeguarsi mimeticamente alla natura anziché oggettivarla”. 1 La sua presenza è incerta, non si mantiene, è rubata, sottratta, fugge, scivola via; la natura non costituisce un’alterità definita, ma piuttosto un misterioso oltre, un universo di cose e di eventi che da ogni parte minacciano e insidiano la presenza. La realtà non è data, non è oggettivata poiché manca ancora lo sguardo di un soggetto; essa non è un possesso garantito, ma un risultato da conseguire, l’esito di uno sforzo che l’uomo tenta di portare a compimento. La realtà è in decisione, in fieri, intenta a costituirsi. La presenza deve ancora raccogliersi come unità di fronte al mondo e, correlativamente, il mondo non è ancora distanziato e differenziato dalla presenza: l’io non è saldamente distinto dal non-io. Se in una civiltà come la nostra, “presenza al mondo” e “mondo che si fa presente” sono costituiti come una dualità decisa e garantita, nella civiltà magica la dualità presenza-mondo non è ancora tale, ma costituisce un problema dominante e caratterizzante che investe l’intera esperienza e la stessa possibilità di avere esperienza. Nella magia il mondo non è ancora deciso e “l’esserci è una realtà condenda ”.2 Il problema del magismo non è dunque quello di conoscere il mondo, o di modificarlo, – azioni che entrambe presuppongono la presenza certa e salda del soggetto-, ma piuttosto di “ garantire un mondo”.
1
Stefano Petrucciani, De Martino, Adorno e le avventure del sé , in Mario De Caro, Massimo Marraffa (a cura di), La filosofia di Ernesto de Martino, “Paradigmi”,anno XXXI, 2013, n.2, p.128 2 Ernesto de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo , Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p.75 9
1.2 Perdere l’anima, perdere il mondo
Quando “ presenza” e “mondo in cui la presenza è immersa” non costituiscono una dualità, quando il confine tra uomo e natura, tra soggetto e oggetto non è ancora definito, perdere l’anima significa perdere il mondo. Io e mondo sono correlati: al rischio individuale di perdere la propria anima è necessariamente e indissolubilmente connesso il rischio di perdere il mondo. Essere presenti significa infatti avere senso in un mondo dotato di senso, pertanto la crisi della presenza coincide con la crisi del mondo nella sua oggettività. Tra uomo e natura non v’è dualità e scarto, ma continuità e omogeneità: se l’io si sfalda, il mondo crolla. Come la presenza implica strutturalmente la possibilità della sua stessa perdita, il mondo, fin dal suo sorgere, comporta il rischio del crollo. Quando la presenza vacilla, quando l’anima è rubata, anche il mondo entra in crisi di orizzonte, trapassa nell’oltre angosciante e minaccioso delle cose, dove “tutto può diventare tutto, che è quanto dire: il nulla avanza”.3
1.3 La crisi della presenza
Il discorso sul dramma magico prende le mosse, in de Martino, dall’analisi di singolari condizioni psichiche nelle quali cadono gli indigeni di alcune tribù, in occasione di emozioni intense, provocate da accadimenti improvvisi e inaspettati. La “crisi della presenza” è innestata dal manifestarsi di realtà particolarmente emozionanti al cospetto delle quali la presenza non riesce a mantenersi, rischiando di perdere se stessa e di “diventare” l’oggetto emozionante. Nello stato psichico latah, presso i Malesi, l’indigeno, venuto a contatto con un contenuto emozionante particolarmente forte, perde l’unità della propria persona e l’autonomia dell’io. La sua presenza cade in soggezione, nella passività dell’ecocinesi e dell’imitazione. Se la sua attenzione sarà attratta dal m ovimento oscillatorio dei rami mossi dal vento, egli imiterà passivamente tale movimento; se vedrà un uomo svestirsi, si spoglierà anch’esso. 3
E. de Martino , Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit., p.123 10
La medesima condizione di imitazione è chiamata, presso i Tungusi, olon. Lo choc procurato da un contenuto emozionante provoca, nello stato olon, la perdita stessa del contenuto come contenuto di una coscienza presente. La presenza non trova cioè l’energia suf ficiente per mantenersi davanti all’oggetto, per riconoscerlo, e per padroneggiarlo, ma resta piuttosto polarizzata in quel certo contenuto, non riuscendo ad andare oltre di esso e perciò abdicando come presenza. Il soggetto che vede le foglie muoversi, “diventa” un albero le cui foglie sono mosse dal vento; il soggetto che ode una parola “diventa” la parola che ode: la distinzione tra presenza e mondo che si fa presente cade. Lo stato olon è da porsi in rapporto con lo stato amok , tipico dei Malesi. Nello stato amok il soggetto perde il controllo delle proprie azioni e, in occasione di emozioni di spavento e di angoscia, diventa preda di uno scatenamento incontrollato di impulsi e di movimenti: “la vittima salta senza sosta, afferra un’arma, corre all’impazzata, colpisce e uccide chiunque incontri sul proprio cammino, anche se si tratta del proprio padre”.4 Gli stati psichici latah, olon e amok , nei quali la presenza si comporta come una eco del mondo, rappresentano il momento negativo della crisi della presenza, il momento in cui si concretizza la possibilità dell’impossibilità di esserci ne l mondo e nella storia. In tali circostanze il soggetto non si afferma contrapponendosi alla natura, ma si riduce a mera imitazione del mondo-ambiente circostante; la sua debole soggettività è vinta e la capacità di trascendenza decade. Il soggetto non è più colui che oltrepassa il dato oggettivo, ma sono piuttosto gli oggetti a trascenderlo: non è intenzionalità ma è, per così dire, intenzionato dalle cose. L’uomo, piuttosto che agire, si trova nello stato di “essere-agito-da”. La crisi della presenza, il suo vacillare, consiste proprio nello svanire di questo confine, nel venire a mancare della linea di demarcazione tra soggetto e oggetto, tra io e mondo.
4
E. de Martino , Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit., p.73 11
1.4 I momenti critici del divenire
La crisi della presenza si verifica in determinati segmenti del divenire 5 che
de
Martino
definisce
come
“momenti
critici”
dell’esistenza.
L’uomo magico è esposto al rischio della labilità nelle sue solitarie peregrinazioni, quando la solitudine, l’oscurità, la ricerca del cibo, il pericolo costituito dagli animali e dal rapporto con lo straniero, e la stanchezza dovuta al lungo peregrinare sopraggiungono a mettere in crisi l’unità della sua persona. ‹‹ Il momento critico dell’esistenza è critico perché impone una decisione e una scelta, un pronto adattamento alla realtà, un comportamento ricco di conseguenze altamente impegnative per la presenza. Il cacciatore davanti alla fiera, l’agricoltore davanti alla tempesta, il pastore davanti alla solitudine, l’uomo davanti alla donna, il guerriero davanti al nemico, lo schiavo davanti al padrone, il giovinetto davanti alla pubertà, i vivi davanti al cadavere; questi momenti critici dell’esistenza sono largamente tradizionali nelle società umane. Il carattere che tutti li lega è che in essi la storia, il divenire, si manifesta, e la presenza prende contatto di un mutamento, di un passaggio, così impegnativi per essa da rischiare di non mantenersi››.6 In tali momenti, di oggettiva difficoltà, è richiesta una presenza umana particolarmente vigile e l’uomo è chiamato ad uno sforzo più alto del consueto: ‹‹in tutti questi momenti la storicità sporge, il compito umano di esserci è direttamente e irrevocabilmente chiamato in causa, qualche cosa di decisivo accade o sta per accadere, costringendo la stessa presenza ad accadere, a sporgere a se stessa, a impegnarsi e a scegliere››.7 Basta una semplice rottura dell’ordine abituale, il verificarsi di un evento appena al di fuori dalla norma, a far precipitare l’uomo nella paralisi della propria presenza: l’incapacità di dare un senso al reale, di comprenderlo -e quindi di dominarlo-, innesta la crisi. Il suono di una campana, una pianta che dà frutti fuori stagione, l ’apparizione di un missionario o un’alterazione improvvisa del paesaggio sono tutti accadimenti “rischiosi”, violazioni che richiedono un compenso, una riparazione riequilibratrice. 5
Tale presupposto teorico sarà fonte di contrasto con Mircea Eliade, per il quale è il divenire in sé, e non solo alcuni segmenti, ad essere caratterizzato da una valenza negativa. 6 Dario Danti, Dalla presenza alla singolarità. Uno studio su Ernesto de Martino , 2007, tesi di dottorato, p.27 7 Ernesto de Martino, Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto , in “Studi e materiali di storia delle religioni”, 1953-1954, 24-25, p.18 12
Proprio a causa del carattere eccezionale degli accadimenti in corso, in questi “momenti critici del divenire” il rischio di non esserci è più intenso, la situazione oggettiva è tale da mettere in dubbio la possibilità di essere umanamente padroneggiata. L’uomo è pervaso da un’angoscia caratteristica 8: “la volontà di esserci come presenza davanti al rischio di non esserci”.9 La sua labilità diventa un problema che sollecita la reazione e il riscatto.
1.5 Polo della crisi e polo del riscatto
Il crollo della presenza rappresenta solo uno dei due momenti di cui è costituito il dramma magico; l’altro momento è quello del riscatto dell’esserci, del porsi della presenza, del “venire alla presenza della presenza ”.10 Dunque il rischio del non esserci, su cui ci siamo finora soffermati, non costituisce che un polo del dramma, un polo che va necessariamente messo in relazione con il polo del riscatto culturale, dell’edificazione di un mondo significativo in cui si è presenti. Per una presenza che “vuole esserci”, la possibilità del suo crollo è un rischio che viene appreso con particolare angoscia. Soltanto quando la labilità della presenza viene avvertita come un problema, e dunque soltanto per l’emergere di tale sentimento d’angoscia, la presenza si apre alla possibilità del riscatto. La problematizzazione della propria labilità è condizione necessaria e sufficiente a farci assistere all’alba del mondo magico. Il crollo della presenza, avvertito come rischio da evitare, come “male” , indica già una prima, fondamentale resistenza. L’avvertimento e il sentimento angoscioso della propria labilità costituisce la genesi del mondo magico, un mondo che non può nascere fino a quando la labilità insorge senza compenso. ‹‹ Per una presenza che crolla senza compenso il mondo magico non è ancora apparso; per una presenza riscattata e consolidata, che non avverte più il problema della sua labilità, il mondo magico è già scomparso››.11
8
Tale angoscia può indurre la paralisi della presenza e la stasi dell’attività valorizzatrice, stasi cui corrisponde il regresso dell’uomo dalla cultura alla n atura. 9 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo,cit., p.73 10 Federico Leoni, La magia degli altri e la nostra. Ernesto de Martino e le tecniche della presenza , in Mario De Caro, Massimo Marraffa (a cura di), La filosofia di Ernesto de Martino, Rivista “Paradigmi”, anno XXXI, 2013, n.2, p.72 11 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit.,p.74 13
Quello magico è un momento che si colloca nell’interstizio tra il crollo effettivo della presenza e la possibilità del crollo; de Martino tiene il crollo “al di qua del suo compiersi”12 e lo rende concreto solo nella coscienza angosciosa della sua possibilità. In altre parole l’abdicazione de facto viene elusa affrontando e combattendo l’angoscia, cioè l’avvertimento della possibilità del proprio nulla. Nel dramma magico si percepisce la dissoluzione dell’esserci come una forza maligna che insidia la presenza e, per combatterla, si entra in rapporto con tale negativo, con tale “maligno”, insomma con la propria angosciosa labilità. Per vincere la labilità occorre saper acquistare il potere di padroneggiarla: occorre la magia.
1.6 La magia come tecnica della presenza
La magia è lo strumento di cui l’uomo del mondo magico si serve per entrare in rapporto con la propria labilità, al fine di domarla. La labilità viene intensificata attraverso tecniche magiche atte a favorire la condizione psichica di trance. L’indebolimento e l’attenuazione dell’esserci è volontariamente perseguito: digiuni, oscurità, solitudine, danze orgiastiche, canti monotoni e narcotici sono tutte pratiche magiche che hanno lo scopo di indebolire l’unitarietà della presenza. L’intensificazione del rischio, il condursi “alle soglie del caos” 13, è infatti la condizione necessaria per dare inizio al riscatto dell’esserci, costituisce il primo passo di “una psichicità che si apre al compito di istituire il suo proprio orizzonte”.14 L’attenuazione della presenza può essere ottenuta mediante la tecnica della ripetizione dello stesso contenuto: cantilene monotone, tambureggiare lento e continuo dei tamburi. L’iterazione dell’identico è infatti incompatibile con l’attività della presenza come unificazione sintetica del molteplice. La ripetizione può essere anche di tipo visivo: prolungata fissazione di un punto o di un oggetto. La monotonia, acustica od ottica, ha lo scopo di polarizzare la coscienza in un certo contenuto e quindi di impedirle di andare oltre di esso, ovvero di essere pienamente presenza. Ma nell’esercizio del ripetere la presenza non si perde completamente: la ripetizione diviene piuttosto il sintomo della capacità dell’esserci di resistere alla minaccia di annientamento. 12
Gennaro Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , Napoli, Bibliopolis, 2001, p.222 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit., p.94 14 Id., p.91 13
14
De Martino ci offre numerosi esempi che mostrano come la magia sia una tecnica della presenza, una strategia elaborata per mantenere, e consolidare, l’esserci dell’uomo nel mondo. La dialettica della presenza tra rischio e relativo riscatto è ben dispiegata nell’analisi dell’atai degli indigeni di Mota. L’atai si costituisce in occasione della percezione di un oggetto che “colpisce l’immaginazione” e che desta meraviglia in chi lo percepisce. È un oggetto, per esempio una pietra, a cui l’individuo associa il suo destino personale: egli vive, prospera, patisce e muore insieme al suo atai. L’atai esprime il dramma della presenza nel mondo esistenziale magico, presenza che, davanti al rischio di annientarsi nel mondo e di essere vinta dall’oggetto, si salva ritrovandosi e trattenendosi nell’alter ego. La dissoluzione della presenza è arrestata mediante questa fissazione e localizzazione in un oggetto, con il quale si stabiliscono rapporti regolati e duraturi. L’ atai costituisce dunque una sorta di compromesso: la presenza che si sta perdendo si riconquista ed è trattenuta fissando la propria unità nell’unità della cosa. Il riscatto è compiuto in questa “esistenza a due”. Il mero abdicare della presenza è arrestato attraverso una creazione culturale suscettibile di sviluppo e di s ignificato; l’atai è il prodotto culturale di una presenza che vuole esserci nel mondo. L’esempio appena esposto non costituisce l’unica modalità di riscatto per la presenza; il riscatto può compiersi infatti anche attraverso pratiche magiche che esprimono il bisogno di allontanare e di separare l’oggetto che insidia la presenza. Tali modalità si attuano soprattutto nei casi che hanno a che vedere con la morte e con i morti. La presenza non riesce a mantenersi davanti l’evento della morte, l’evento negativo per eccellenza, ed esprime l’avvertimento di questo rischio nella rappresentazione del cadavere che “contagia”, che ruba e che succhia l’anima. Il cadavere deve dunque essere allontanato, separato dal mondo dei vivi. I riti funerari degli Arunta, presi ad esempio da de Martino, hanno lo scopo di produrre questo allontanamento, di creare una distanza tra il cadavere e i viventi. La capanna del defunto viene distrutta per impedire che vi faccia ritorno, la terra che ricopre il cadavere calpestata per renderla più compatta, il suo nome non può essere pronunciato, poichè la parola rischia di diventare la cosa significata. I vivi gridano
15
intorno alla tomba per scacciare il morto e vi depongono ossa, in modo che il morto possa riconoscersi in esse. Soltanto apparentemente il rito funebre è il rito compiuto dai vivi intorno e per i morti, in realtà la serie di atti che vengono compiuti nascondo no un’operazione più importante e radicale: quella del tracciamento di un confine, di una linea di separazione. Il rito, e l’oper azione magica in generale, vogliono introdurre una distanza, stabilire una non-coincidenza. I vivi vogliono assicurarsi dalla malevolenza dei defunti, garantirsi dallo spettro della morte. Il rito magico è così una tecnica della presenza in quanto è anche una tecnica dell’assenza: rendendo assenti i morti, rende presenti i vivi; produce un oggetto, il morto, in modo tale che i vivi possano “gettarlo davanti” a sé. Solo una volta oggettivata la morte, solo una volta “ proiettata davanti”, si potrà creare lo spazio della presenza, lo spazio del soggetto. Il rito, distinguendo tra presenza e assenza, introduce una differenza tra soggetto e oggetto. Tutte le operazioni magiche, tutte le tecniche della presenza hanno a che fare con la costruzione di questa distinzione, con lo stabilire questa distanza.
1.7 Il “Cristo magico”: lo sciamano
Al centro del mondo culturale magico emerge la figura dello sciamano, definito da de
Martino
come
“l’eroe
della
presenza”,
il
“Cristo
magico”.15
Lo sciamano è l’uomo che si apre al dramma esistenziale dell’esserci, che affronta il rischio della dissoluzione e riporta una conquista non solo per se stesso, ma per la tutta la comunità. Lo sciamano si porta al limite della propria presenza per nascere di nuovo; disfa il suo esserci per rifarsi, “ridiscende al suo ci per ripossedersi”.16 Nello sciamano il “perdersi” costituisce la prima tappa del processo che conduce alla “salvezza”, all’approdo alla presenza. Egli provoca intenzionalmente la “crisi del ci sono” attraverso forme controllate, ripete il dramma in ciascuna delle sue fasi. Il non esserci, la forza 15
Id.,p.98 Ibidem
16
16
demoniaca e maligna che insidia la presenza, è riplasmato dallo sciamano in una serie definita di “spiriti” che vengono così identificati e padroneggiati. Attraverso la sua figura il rischio della labilità viene riassorbito nella demiurgia umana, diventa un momento del dramma culturale. Un esempio: soffia un forte vento, percepito come maligno in quanto realtà che ruba l’anima, lo sciamano lo osserva attentamente e vi legge le forme che lo travagliano: lunghi gatti demoniaci. Solo lo sciamano può vederli, solo lui può combatterli, getta contro di loro pietre e poi li uccide con dei bastoni. Compiuta l’operazione l’oltre minaccioso del vento è stato esorcizzato: tutta la comunità è salva dalla forza maligna che minacciava la sua presenza. Attraverso lo sciamano la comunità si dota di un mezzo potente, munito di reale efficacia, che combatte e che cura la labilità degli individui. Lo sciamano incarna il dramma esistenziale di tutta una collettività: attraverso di esso la comunità nel suo complesso “si apre alla vicenda dell’esserci che si smarrisce e si ritrova”.17 Governando e amministrando l’angoscia, volgendola verso una determinata fine, il “Cristo magico” prepara “la risalita dagli inferi verso la luce”. 18 I drammi esistenziali di tutti, le esperienze individuali di crisi della presenza, non restano “isolate e irrelative” 19 le une rispetto alle altre, ma, grazie al l’azione salvifica dello sciamano, si modellano secondo uno schema comune, si appoggiano alla tradizione, vengono cioè culturalmente regolate.
1.8 Istituti storici della magia: fattura e imitazione
Lo sciamano è chiamato a fronteggiare non solo le crisi di labilità suscitate dagli accadimenti naturali dell’esistenza quotidiana , ma anche quelle intenzionalmente provocate e indotte da altri stregoni. Compito dello sciamano sarà, in questo caso, quello di annullare l’effetto della malia compiuta, di opporre alla fattura una controfattura.
17
Id.,p.94 G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p.230 19 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit., p. 98 18
17
‹‹Non c’è dubbio che un Arunta morirà per una ferita, anche superficialissima, se crederà che l’arma che ha causato la ferita sia stata affatturata ( sung ), e dotata di arungquilta. Egli si accascia, rifiuta il cibo, e deperisce››. 20
‹‹Un altro uomo […] si prese un leggero raffreddore, ma lo stregone del luogo gli disse che i membri di un gruppo a circa venti miglia a est gli avevano portato via il cuore: la qual cosa credendo, l’uomo si accasciò e andò in consunzione››.21 ‹‹[…]Venne da noi un uomo con una leggere ferita alla schiena. Gli fu assicurato che la ferita non era grave, e fu curato come si suole in casi simili. Ma l’uomo persisteva nel dire che la freccia era stata affatturata, e che essendo la sua schiena rotta, sebbene in modo invisibile, egli doveva morire: come infatti morì››.22 Questi esempi servono a mostrarci quanto sia reale e concreto il rischio a cui è esposto colui che crede di essere affatturato; ma altrettanto reale ed efficace è l’eliminazione del rischio ad opera della contro-fattura. Fattura e contro-fattura acquisiscono rilievo di importanza storica; tramite esse il rischio di non esserci è “umanizzato”: non proviene più dal di fuori, non insorge accidentalmente nelle notti di tenebra o durante solitarie peregrinazioni, ma è volontariamente prodotto dall’uomo e dalla sua intenzionalità. Attraverso gli istituti storici della fattura e della contro-fattura l’uomo partecipa attivamente al dramma esistenziale magico e ne controlla i momenti: producendo il rischio è anche in grado di superarlo. ‹‹Nell’autentica realtà delle cose, là dove sul serio la presenza si perde, come soggetto, nell’anonimia della natura, ed è foglia che stormisce, vento che soffia […]; nel luogo in cui a dominare è la morte, il dramma è un dramma, anzi una tragedia, un colpo fatale che […] cade sulla presenza e la schianta. Nella realtà ritualizzata della tecnica magica, nel dramma che vi è prodotto e mimato, la tragedia è un dramma; che, avendo un inizio controllato, per questo può anche esserlo nel suo esito; che non è perciò la tragedia della morte, ma il riscatto da questa››.23
20
Id.,p.105 Ibidem 22 Ibidem 23 G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p. 231 21
18
Un altro importante istituto magico, caratterizzato da una concreta finalità e da una funzione reintegrativa, è quello dell’imitazione. Quando è storicamente definita e socialmente istituzionalizzata, l’imitazione non è passiva ecocinesia o mera coinonia tra soggetto e oggetto. La presenza viene piuttosto riscattata mediante la imitazione “attiva e finalistica”24: l’individuo imita i rami mossi dal vento allo scopo di produrre il vento, mima la pioggia perché vuole far piovere, imita il fuoco per mantenerlo vivo. L’imitazione rende l’azione del singolo un’attività demiurgica finalizzata ad un determinato scopo; attraverso essa l’individuo recede dalla passività dell’ecopsichismo, compie il riscatto dalla presenza immediata e si fa centro attivo delle sue azioni.
1.9 Il valore culturale del dramma magico
Grazie all’istituto magico l’individuo e la comunità si sentono protetti dal “negativo” della vita, dall’incertezza, dalla precarietà, dai problemi che l’esistenza quotidiana comporta. La magia si determina, dunque, come una strategia di resistenza alla crisi, come una tecnica elaborata per proteggere e consolidare l’esserci nel mondo. Nel dramma magico non si verifica mai la caduta totale della presenza, essa vacilla, è in bilico, ma non decade. Vale a dire, nel mondo magico il polo del riscatto è prevalente: domina la presenza che si riscatta. La magia genera un orizzonte culturale che permette di fronteggiare, e di superare, la crisi; mediante le sue pratiche la presenza è reintegrata. Attraverso i suoi istituti, attraverso un sistema di compensi e di compromessi, la magia segnala e combatte il rischio, arresta il caos insorgente e lo riplasma in un nuovo cosmo, “recupera per l’uomo il mondo che si sta perdendo”. 25 L’operare magico è storico e culturale; il nuovo orizzonte plasmato dalla magia si rifà a modelli culturalmente e intersoggettivamente validi. Il dramma magico non si astrae dalla sua storicità, vi è piuttosto immerso, e riceve senso e valore dall’ambiente storico-culturale in cui ha luogo.
24
E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit., p.111 Id.,p.123
25
19
Nella civiltà magica il dramma non è individuale ma comune a tutti, si inserisce organicamente nella cultura, è sapientemente mediato da tradizioni accreditate e da istituti definiti. La civiltà non è sprovvista di mezzi al cospetto di tale dramma esistenziale; essa segue il filo della tradizione, si avvale dell’esperienza accu mulata dalle passate generazioni, “la struttura della civiltà è preparata a sciogliere quel dramma”.26 Nella comunità storica la presenza si salva perché la sua tragedia non è irrelata, non è individuale; l’esserci si riscatta perché è accolto e compreso da una cultura. Il mondo magico fonda una civiltà, “una civiltà che accenna a noi, uomini moderni”.
27
1.10 Le realtà del mondo magico
Il mondo magico, in quanto “mondo in decisione”, implica delle forme di realtà che nella nostra civiltà, caratterizzata da una presenza decisa e garantita, sono polemicamente negate e impossibili da concepirsi. La realtà onirica, la realtà del doppio degli oggetti, degli spiri ti, dell’eco, del prolungamento ecc. sono tutte forme che comportano una presenza indefinita e ancora intrecciata con l’ambiente, un esserci in fieri, ancora in via di decidersi. I fenomeni cosiddetti paranormali si configurano come possibili, come reali, per entro un mondo che non è dato, ma ancora tutto incluso nella decisione di una presenza umana che vacilla. Così come i fatti della natura presuppongono un mondo dato, una realtà esterna osservabile e quindi una presenza autonoma e stabile, gli eventi paranormali presuppongono una presenza insidiata, esposta al rischio, un esserci che si sta ancora cercando. Per meglio comprendere la realtà, o meglio le realtà, del mondo magico, de Martino racconta un caso esplicativo: in Paraguay, un indigeno lengua accusò un missionario, un certo Grubb, di aver rubato le sue zucche. L’indigeno era certo del furto e dell’identità del ladro poiché lo aveva visto chiaramente in sogno compiere tale atto. Per quanto ci riguarda saremmo portati a dire che l’indigeno è un folle, che sbaglia ad affidarsi ad un
26
Id.,p.151 Id.,p.152
27
20
sogno e che il sogno non prova niente. Eppure, dice de Martino, le cose “non stanno proprio così”.28 Il nostro concetto di presenza, così come il nostro concetto di realtà, presupponendo scontatamente il processo storico del costituirsi del “ci sono”, non p ossono penetrare il mondo magico. In un’epoca storica in cui “la presenza non si è ancora nettamente decisa nel senso della veglia, in una civiltà in cui la presenza e il mondo che si fa presente si estendono nel senso della coscienza onirica, e il reale culturalmente significativo include anche ciò che è vissuto da questa coscienza” 29 è ben possibile che Grubb abbia rubato le zucche. Se affermiamo che il missionario “in modo assoluto e sotto tutti i rapporti” non ha rubato le zucche, non facciamo altro che restare prigionieri del nostro concetto di realtà, imponiamo forzatamente la nostra concezione come assoluta e valida in tutte le epoche e per tutte le civiltà. In realtà vi sono due Grubb: quello che fa parte della nostra cultura, della visione occidentale della presenza e del mondo come realtà date, e quello inserito nel contesto del dramma magico, della presenza indefinita che si intreccia col mondo, del pensiero che non è disgiunto dalla realtà. Un terzo Grubb, un G rubb “in sé” assolutamente vero non esiste. In un mondo in cui le presenze sono ancora indefinite, e in cui spazio e tempo sono inclusi nella decisione umana, l’individuo può “teletrasportarsi” in luoghi distanti, può leggere nel pensiero, comunicare telepaticamente o visitare realmente altri individui in sogno. Fin quando l’esserci costituisce un problema dominante e caratterizzan te la fattura ammalia, la contro-fattura salva; se l’atai muore, muore anche colui che vi è legato. Questi tipi di eventi fanno parte della decisione e dell’intenzionalità umana. Se vogliamo addentrarci nella civiltà magica dobbiamo mettere da parte la positività e la datità del nostro mondo, liberarci dai nostri limiti storiografici e tenere presente che
abbiamo a che fare con un’altra forma di realtà, legata ad un diverso ordine storico e culturale: dobbiamo renderci conto che “qui è in gioco una forma di realtà che non è la datità”.30
28
Id.,p.135 Id.,p.136 30 Id.,p.134 29
21
L’uomo di scienza occidentale deve resistere alla dannosa ed erronea tentazione di volere inserire i fenomeni paranormali nel nostro ordine fisico, nel nostro mondo dato e osservabile. I fatti paranormali non sono assimilabili ai fatti della natura, non sono indipendenti, “gettati davanti”, “oggettivi”, ma sono atti che si danno “per l’intervento di una presenza che li costruisce immediatamente nell’impegno storico di distinguersi dal mondo e di contrapporsi ad esso”.31 I metodi della nostra scienza, nati per indagare i fenomeni che appartengono ad un mondo dato, non sono adattabili ad un mondo che deve ancora darsi e decidersi. Riportare i fenomeni alla forma dell’esperimento, ridurli ad un’osservazione e ad una valutazione li strappa “dalla concretezza della loro forma storica e spontanea” 32, li priva del loro lato “più propriamente umano e culturale”.33 I poteri magici non devono essere scientificamente spiegati ma storicamente compresi; e possiamo com-prenderli solo nella misura in cui li inseriamo nel dramma esistenziale da cui sgorgano, solo mediante la ricostruzione culturale dell’epoca in cui sono inseriti.
1.11 La critica al soggetto trascendentale kantiano
De Martino, muovendo dalla sua ricerca empirica, compie una radicale critica al soggetto trascendentale kantiano. Il principio dell’autonomia della persona, individuante e caratterizzante la civiltà occidentale, raggiunge il suo apice ideale con la scoperta kantiana dell’unità trascendentale dell’autocoscienza. Affinchè sia possibile il contrapporsi di un’unità soggettiva ad un mondo oggettivo, e affinchè sia possibile che io resti identico a me stesso nel rappresentarmi la molteplicità e la mutevolezza dei contenuti e delle esperienze, è necessaria l’unità trascendentale dell’autocoscienza: l’ Io Penso. L’ Io Penso, o l’appercezione, è la funzione che svolge l’attività di sintesi e di unificazione del molteplice, e lo riporta all’unità della coscienza. È grazie a tale sintesi se il pensiero dell’io non varia con i suoi contenuti ma li comprende come suoi. In altre parole l’appercezione è la potenza che rende poss ibile un mondo fenomenico oggettivo. 31
Id.,p.132 Id.,p.40 33 Ibidem 32
22
La coscienza che io ho di me come soggetto pensante, l’identità dell’autocoscien za, mi permette di avere delle rappresentazioni del mondo. Un oggetto è tale solo in rapporto ad un soggetto, dunque in ciascun dato percep ito dall’io è presupposta la totalità della coscienza. L’unità trascendentale dell’autocoscienza, fondando la possibilità dell’autonomia della persona, fonda parimenti la possibilità del crollo di questa autonomia. L’unità kantiana dell’appercezione è cioè soggetta al rischio esistenziale di perdersi. ‹‹ […]il supremo principio dell’unità trascendentale dell’autocoscienza comporta un supremo rischio per la persona, e cioè, appunto, il rischio per essa di perdere il supremo principio che la costituisce e la fonda››.34 Tale rischio insorge quando la persona non riporta all’unità della coscienza i contenuti che esperisce bensì li lascia liberi dalla sintesi, non padroneggiati; la persona abdica cioè al suo compito, non è autonoma in rapporto ai contenuti e pertanto rischia di scomparire come presenza. L’esserci della persona implica costantemente il rischio di perdere quello stesso essere, l’autocoscienza che la cost ituisce e che la fonda. Vale a dire, la presenza, nel momento del suo stesso costituirsi, fonda simultaneamente il rischio di smarrirsi. La presenza e il mondo quali realtà date restano, in Kant, al di fuori del processo storico, non vengono individuati come prodotti di formazione storica. La presenza viene così “congelata”, irrigidita, non le viene r iconosciuto il suo essere correlativa alla civiltà occidentale: ‹‹si ha la ipostasi metaf isica di una formazione storica››.35 La presenza di stampo kantiano, l’esserci de ciso e garantito, viene assunto dalla nostra civiltà come il modello di ogni possibile presenza, come l’archetipo valido per entro qualsiasi mondo storico e culturale. L’esserci unitario della persona ‹‹ si configura come il mai deciso o (che poi è lo stesso) come il sempre deciso, e perciò stesso come ciò che non entra nel mondo delle decisioni storiche››.36 Cioè entrano nella storia ‹‹soltanto lo scegliere e il decidere per entro le forme dell’arte, del linguaggio, della religione e del mito, del sapere scientifico, della economicità, della politicità, del diritto. Ma non entra
34
Id.,p.158 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, cit.,p.160 36 Ibidem 35
23
nella storia lo scegliere e il decidere per entro la forma fondamentale- il “supremo principio” principio”- dell’unità trascenden tr ascendentale tale dell’autocoscienza›› dell’autocoscienza››..37 De Martino ci presenta il soggetto trascendentale kantiano, ovvero la condizione di possibilità di ogni oggettività, come un momento, esso stesso, del mondo oggettivo. La fonte di ogni oggettività cioè non è essa stessa in oggettivabile ma costituisce l’esito di un determinato processo storico. La suprema unità sintetica dell’autocoscienza vien e immersa nel mondo come un momento storico tra gli altri: “la categoria giudicante è presa come altrettanto storica della storia che ne è giudicata”.
38
In altre parole il
principio costituente si ritrova a sua volta una realtà costituita. ‹‹La ‹‹La situazione si configura quindi come paradossale, ciò che si presentava in prima battuta come orizzonte includente si trasforma in un elemento incluso inc luso in questo stesso orizzonte››. orizzonte›› .39 A parere di de d e Martino l’”errore l’”errore”” compiuto da Kant è di avere assunto l’unità trascendentale dell’autocoscienza come un presupposto incondizionato, un immediato, un a-priori universalmente valido e garantito. Ma il concetto di presenza non è un invariante metastorico, non si sottrae al divenire; è esso stesso una forma storica, un prodotto umano che che deriva da una determinata civiltà. civiltà. La presenza è un punto d’arrivo reversibile, un approdo contingente. Essa è parte della storia, ed è, pertanto, es posta es posta allo sviluppo e al dramma; l’error e che deriva da Kant è l’oblio di di tale fatto. ‹‹[…] Mentre la ragione storica è andata molto innanzi nella ricostruzione storiografica per entro vari modi categoriali di realtà, rispetto all’unità trascendentale dell’autocoscienza dell’autocoscienza essa non ha fatto v alere la sua propria esigenza››. esigenza›› .40 L’esserci non è un immediato originario, non è un “sempre dato” dato” che ci proviene dalla natura, ma è un risultato mediato, un traguardo faticosamente, ma non conclusivamente, conclusivamente, raggiunto. La presenza è un bene culturale conquistato dall’uomo attraverso attraverso lotte, sconfitte, compromessi, attraverso decisioni e scelte che rinnoviamo ogni giorno.
37
Id.,p.159 G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p. 250 39 S.Petrucciani, M. De Caro, M. Marraffa (a cura di), cit.,p.131 40 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una una storia del magismo, cit.,p.160
38
24
1.12 Del magico si può, si deve, fare storia
La magia rivela il suo vero significato e senso solo quando è mostrata nella sua concreta finalità e funzione: proteggere l’esserci insidiato, insidiato, garantire la presenza, fondare e ordinare il mondo. Diversamente da quanto sostenuto dai precedenti studiosi del magismo e dai cosiddetti irrazionalisti, come Lèvy-Bruhl 41, il mondo magico non è il regno della pura irrazionalità e del caos; bensì esso mette capo ad un cosmo padroneggiato padroneggiato dall’uomo e dalla sua intenzionalità. Gli irrazionalisti avevano individuato il dramma del mondo magico, ma si erano fermati alla considerazione del suo polo negativo, al momento della crisi della presenza, senza accorgersi che il mondo magico è in realtà dominato dal polo del riscatto e dallo sforzo attivo di sottrarsi al rischio r ischio di non esserci. Tutto il sistema di istituti, di compensi, di guarentigie e di compromessi che la magia mette in piedi sono infatti orientati al mantenimento e al consolidamento della presenza, sono finalizzati alla fondazione dell’esserci de ll’esserci elementare dell’uomo. Nel mondo magico scorgiamo il primo drammatico cenno della volontà umana di istituirsi come presenza in un mondo definito. Tutto ciò rende il magismo un fenomeno culturale storicamente determinato. Nel magico dunque non v’è solo dramma, non v’è solo negativo. Il magismo non è la “potenza di cui ci si spoglia nel processo della ragione” 42, come sostenuto polemicamente da Adolfo Omodeo43, e per il quale, di conseguenza, del magico non può darsi storia, “perché la storia si può fare del positivo e non del negativo” .44 Sottratta all’irrazionale la magia rivela la sua autentica storicità. Se la separiamo dalla determinatezza storica in cui è immersa non possiamo comprenderla; il fenomeno magico riceve leggibilità soltanto alla luce della salda giuntura che lega la magia alla
41
Lucien Lèvy-Bruhl (1857-1939) antropologo, sociologo, filosofo ed etnologo francese. Ha condotto studi sulla mentalità religiosa dei popoli arcaici, a seguito dei quali ha elaborato la “teoria del prelogismo” dei primitivi. Si veda, a questo proposito, La mentalitè primitive, 1923 42 E. de Martino , Il mondo magico. Prolegomeni a una una storia del magismo, cit., p.162 43 Adolfo Omodeo, maestro di de Martino con il quale si laureò presso l’università di Napoli nel 1932, e che lo introdusse nella cerchia di Benedetto Croce. In una lettera datata 1941, Omodeo osservava, in polemica con de Martino, che “ a rigore di logica la storia del magismo non esiste”. 44 Critica riportata da Adolfo Omodeo e altresì supportata da Benedetto Croce. 25
storia. ‹‹Rilievo ‹‹Rilievo storico avrebbe solo una ricerca volta a determinare la Weltanschauung del magismo e la funzione storica di tale Weltanschauung ››. ››.45 De Martino coglie l’essenza del l’essenza del mondo magico e ne rivendica la piena storicità, ne fa oggetto di una problematica storiografica autonoma. L’elemento magico, nella storia della civiltà, svolge un ruolo “culturale, salvifico, eroico, pedagogico” 46. Del magismo dunque si può, e si deve, fare storia.
1.13 Dasein e Dasein-sollen : un confronto con Heidegger
Al rapporto tra presenza e perdita della presenza fa da sfondo il dibattito esistenzialista su essere e non essere. L’esserci demartiniano è un concetto in costante sviluppo, la sua evoluzione è determinata dalle differenti contaminazioni filosofiche e culturali che si succedono nel corso dei suoi studi (Croce, Janet, Storch, Jaspers, Abbagnano, Heidegger). Per Heidegger il modo d’essere del Dasein è l’esistenza. L’esserci, che che nella sua struttura trascendentale implica sempre l’essere l’esse re in un mondo, ha diverse modalità di essere-nel-mondo: può scegliere sce gliere tra l’alternativa di una vita autentica autent ica o di una vita inautentica. ‹‹Appunto perché l’Esserci è essenzialmente la sua possibilità, questo ente può, nel suo essere, o “scegliersi”, “scegliersi”, conquistarsi, oppure perdersi e non conquistarsi affatto, o conquistarsi conquistarsi solo “apparentemente”›› “apparentemente”››..47 Per Heidegger l’esistenza umana è per lo più inautentica. Tale esistenza anonima è insita nella stessa struttura esistenziale dell’uomo. La deiezione, cioè lo scadimento dell’esserci nella dimensione anonima e inautentica della vita, la caduta dell’essere dell’uomo al livello delle cose del mondo, è una forma di alienazione connaturata all’essenza umana. In Heidegger il Dasein coincide con l’angoscia, il l’angoscia, il negativo è dunque insito nella stessa struttura dell’esserci. dell’esserci . La morte concerne l’essere stesso dell’uomo, costituisce la la sua possibilità più autentica e più propria. L’Esserci d i Heidegger è pertanto attraversato attraversato da una negatività negatività strutturale.
45
E. de Martino, Naturalismo e storicismo nell’etnologia, Laterza, Bari, 1941, p.74 Sergio Fabio Berardini, De Martino, Croce e il problema problema delle categorie , in Ivan Pozzoni (a cura di), Benedetto Croce. Teoria e orizzonti , Limina Mentis, 2010, p.340 47 Martin Heidegger, Sein und Zeit , Tubingen 1927; trad. it . Essere e tempo , a cura di A.Marini, Mondadori, 2011 p.65 46
26
In polemica con tale esistenzialismo negativo de Martino non intende l’esserci come deiezione. Per egli il Dasein non è esso stesso angoscia; l’angoscia è piuttosto la paralisi
della presenza e la sofferenza che questa paralisi provoca all’esserci che ne è vittima, l’angoscia è il sentimento di chi avverte il venir meno della propria presenza, della propria capacità di emergere nel mondo. Di conseguenza il crollo del mondo, che coincide con la vita inautentica, non è una modalità di essere-nel-mondo, e quindi una possibilità strutturale dell’esserci, ma costituisce un rischio radicale, una minaccia permanente. La negatività dunque non è situata nel cuore dell’esserci, ma si configura piuttosto come un pericolo da combattere, come una possibilità da scongiurare. L’esserci demartiniano è un esserci in cui «il ci si configura storicamente entro contesti storico-culturali determinati; altrettanto storicamente determinati sono presenza e mondo››.48 De Martino sottolinea il carattere sociale di un uomo situato entro una tradizione culturale definita; di un uomo che, mediante la cultura e la forza del valore, lotta contro il rischio, contro il negativo e contro la “morte”. In tale ottica acquista rilievo il rischio di non-poterci-essere-nel-mondo e, quindi, il doveroso impegno umano di combattere tale rischio, di trascenderlo mediante la fondazione di un ordine culturale. Tale trascendimento è il vero principio in forza del quale diventa possibile un mondo in cui si è presenza. Concludendo, per de Martino il fondamento dell’umana esistenza non è l’es sere ma il “dover essere”. L’esserci non è essere-nel-mondo ma doverci-essere-nel-mondo. Dasein come Dasein-sollen, in-der-Welt-sein come in-der-Welt-sein-sollen. In questa
profonda differenza sta la netta distanza tra il Dasein di Heidegger e l’esserci demartiniano.
1.14 Il rischio antropologico permanente
Il dramma del mondo magico non è una tappa ormai archiviata del processo evolutivo dell’uomo, ma è un momento che fa strutturalmente e costituzionalmente parte dello stesso essere umano. In un certo senso possiamo dire che siamo tutti, sempre, potenziali abitanti del mondo magico. 48
Clara Gallini, Introduzione alla Fine del mondo, Torino, Einaudi, 1977, p.LII 27
La presenza non è conquistata una volta per tutte, ma è sempre precaria e soggetta alla reversibilità; è un prodotto, il risultato conseguito da uno sforzo umano che si dispiega nella storia, è un possesso temporaneo che, in qualsiasi momento, può venire a mancare. Il nostro approdo alla presenza non è mai conclusivo e definitivo, ma perennemente esposto
all’evenienza
della
catastrofe
e
alla
possibilità
del
regresso.
La presenza, la conquista di un Io stabile, è un bene storico e, come tale, revocabile. Nella vita dello spirito tutto, a partire dallo spirito stesso, può essere rimesso in discussione. La perdita della presenza è dunque un’eventualità sempre incombente per l’uomo, un rischio ubicato nel cuore del suo stesso esserci. Il tragitto che porta alla formazione del Dasein non è a senso unico. La presenza non conosce porto sicuro, mai è al riparo ma sempre esposta al rischio del suo stesso abdicare. La crisi della presenza, il pericolo del suo sfaldarsi, costituiscono un rischio antropologico permanente, un carattere fisiologico dell’animale umano.
28
II. APOCALISSI CULTURALI
‹‹ Certo il mondo “può” finire: ma che finisca è affar suo, perché all’uomo spetta soltanto rimetterlo sempre di nuovo in causa e iniziarlo sempre di nuovo››. Ernesto de Martino
Il rischio di perdersi, di “non esserci più nel mondo”, è costitutivo della stessa condizione umana; tale rischio non appartiene solamente all’orizzont e esistenziale dei “primitivi”, ma è connaturato all’essere stesso dell’uomo, è consustanziale ad ogni presenza ed esistenza umana. Il tema della difesa della presenza dalla crisi va dunque oltre il magismo e i confini del mondo magico, dilegua nel mondo “adulto”, e investe anche quelle dimensioni in cui l’esserci appariva un possesso garantito.
2.1 Magia e religione
Se il rischio della precarietà è ineluttabile, altrettanto lo è l’esigenza di simbolismi protettivi, volti ad assicurare la presenza umana nel mondo e a farla essere nella storia.
Al pari della magia, anche la religione si rivela una tecnica finalizzata ad impedire il naufragio della presenza. Ambedue sono infatti accomunate dalla funzione di elaborare strategie per garantire l’esserci nel mondo. Entrambe agiscono in situazioni-limite, in momenti critici in cui il confine tra natura e cultura rischia di scomparire; entrambe, ognuna coi propri istituti, operano a favore della rifondazione di tale confine.
29
Magia e religione partecipano alla sfera del sacro. Nell’ottica di de Martino il sacro costituisce un dispositivo di protezione, è un prodotto culturale creato dalla civiltà allo scopo di arginare il rischio della perdita della presenza. La tecnica religiosa, parimenti a quella magica, salva l’uomo dalla caduta nella mera natura, assicura il persistere di un mondo culturale. Il discorso sulla presenza, tesa tra la possibilità di esserci e del non-esserci, si rivela dunque inscindibile dal discorso sugli istituti protettivi magico-religiosi.
2.2 La ierogenesi come tecnica
Secondo de Martino la “potenza tecnica dell’uomo” è un apriori, non solo quando si volge “al dominio della natura con la produzione di beni economici, con la fabbricazione di strumenti materiali e mentali del pratico agire” 49, ma anche, e soprattutto, quando fa consistere il suo compito nell’impedire il naufragio della presenza. Per Rudolf Otto50 il sacro rinvia innanzi tutto alla dimensione dell’alterità radicale, del totalmente altro. Gli strumenti conoscitivi dell’uomo appaiono, in quest’ottica, inadeguati a comprendere la complessa realtà del numinoso: il sacro, Das Ganz Andere, è nozionalmente inconcepibile e, quindi, irrazionale. L’uomo è fascinato e terrorizzato dal numinoso, lo esperisce, o meglio lo subisce, con un sentimento di inadeguatezza e di inferiorità. L’alterità del sacro è concepita da Otto come una realtà ontologicamente data, di fronte alla quale l’uomo non può che lasciarsi “agire -da”. De Martino discorda radicalmente da questa tesi asserendo che il sacro non è un a-priori ma costituisce un prodotto, è il risultato di un determinato processo la cui genesi è integralmente, pienamente, umana. Pertanto non vi è irrazionalità nel numinoso, il sacro va piuttosto concepito alla stregua di un discorso razionale, mondano e prettamente storico: il sacro costituisce appunto una tecnica.
49
G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p.287 Rudolf Otto (1869-1937), storico delle religioni tedesco il cui pensiero sarà alla base della futura sociologia e filosofia della religione. La sua opera più importante, dove elabora un concetto del “sacro” che avrà larga fortuna e diffusione, è “ Das Heilige”, pubblicata nel 1917. 50
30
La drastica alterità che lo qualifica non ha alcun carattere di assoluto, ma riflette piuttosto l’alienazione della presenza (del sé) che nell’esperienza della crisi si vi ve come “altro da sé”. ‹‹Ben si comprende, in questa prospettiva, perché l’esperienza del sacro contenga sempre il manifestarsi di una forza completamente altra, assolutamente separata dal profano, demoniaca e rischiosa: è il momento in cui la presenza recede inorridita davanti al processo della sua propria alienazione, davanti al sé che diventa altro ››.51 La religione è quel dispositivo culturale che, nell’ambito del sacro, arresta l’alienazione della presenza, svolgendo pertanto un ruolo terapeutico e salvifico, assolvendo ad una funzione reintegrativa e coesiva. La religione è fonte e strumento di salvazione: ‹‹aiuta a vivere non già nel senso generico e banale dell’espressione ma nel senso profondo che recupera e mantiene la base essenziale della vita umana››.52
2.3 La destorificazione religiosa
La tecnica promossa dall’istituto religioso, al fine di proteggere la presenza umana nel mondo, è quella della destorificazione. Destorificare vuol dire negare, occultare la storia. L’istituto della destorificazione interviene nei momenti critici dell’esistenza e, sottraendoli all’iniziativa umana 53, opera un “mascheramento della storia angosciante” 54; provvede cioè a negare l’oggettiva difficoltà dell’accadimento in corso, presentandolo come se fosse la ripetizione di un evento analogo già verificatesi in passato, nell’illud tempus del mito. In questo modo la difficile situazione contingente non viene affrontata nella sua cruda e problematica storicità, ma viene rappresentata come la replica di un episodio già vissuto e quindi suscettibile di essere superato. La criticità del momento in questione è risolta nell’iterazione di un “da sempre valido” ordine risolutore , e risulta pertanto depotenziata.
51
E. de Martino, Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto, cit., p.17 E. de Martino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro , Lecce, Argo, 1995, p.62 53 Questo non significa che non avvengano innovazioni, iniziative o modifiche ma semplicemente che queste hanno luogo solo se mascherate nella loro storicità. 54 Ibidem 52
31
L’operazione della destorificazione garantisce il “compito umano di esserci” mediante l’istituzione di un piano metastorico che assolve a due funzioni: fonda un orizzonte rappresentativo stabile e, allo stesso tempo, fornisce il luogo ideale in cui, attraverso l’iterazione di modelli operativi, può essere riassorbita, a nnientata o sospesa, la nefasta potenza del negativo. ‹‹ In virtù del piano metastorico come orizzonte della crisi e come luogo di destorificazione del divenire si instaura un regime protetto di esistenza, che […] getta un velo sull’accadere e consente di stare nella storia come se non ci si stesse››.55 Il “come se” costituisce una modalità di “superamento culturale dell’esistente” 56 e può essere considerato il segno distintivo della destorificazione religiosa. Il presente critico viene assimilato all’esistente da sempre, ad un paradigma in cui la crisi si è risolta in maniera positiva. Il rischio di alienazione delle singole presenze viene trasfigurato in un ordine metastorico, e riportato in un quadro rappresentativo stabile e tradizionalizzato. Gli uomini si comportano e agiscono come i protagonisti dei miti, attraverso il rito rinnovano lo spazio e il tempo mitico, evocano il rassicurante orizzonte della metastoria. Mediante tale prassi mitico-rituale la presenza si mantiene intatta. ‹‹[…] la decisione umana di quei momenti si svolge per entro la protezione della già avvenuta decisione sul piano mitico, il che equivale a dire che attraverso la pia fraus dello stare nella storia come se non ci si stesse viene ridischiuso lo starci effettivo della operosità profana, garantito nei suoi risultati e nelle sue prospettive dal già deciso in illo tempore››.57
Mentre la crisi contingente non offre alcuna certezza di essere risolta, la crisi riplasmata nei modi del mito e del rito comporta la reintegrazione culturale. Dunque la destorificazione, quando è culturalmente disciplinata e socialmente istituzionalizzata 58, svolge un ruolo positivo di grande portata. La storia, e il negativo che vi è al suo interno, non viene rimossa dalla coscienza, ma collettivamente assunta e fatta oggetto di pratiche umane il cui valore è socialmente condiviso. 55
E.de Martino, Sud e Magia, Milano, Feltrinelli, 2001, p.97 Giovanni Filoramo, Marcello Massenzio, Massimo Raveri, Paolo Scarpi, Manuale di storia delle religioni, Bari, Laterza, 2009, p.530 57 E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , Clara Gallini (a cura di), Torino, Einaudi, 1977, p. 222 58 Cioè quando non è irrelata, quando non è una insorgenza spontanea del singolo individuo. 56
32
Strumento primario ed indispensabile della destorificazione è il simbolismo miticorituale. Di conseguenza la religione è essenzialmente mito e rito. Il mito offre il modello metastorico del quale il rito compie l’iterazione. Il rito, con parole e gesti definiti, ripete, narrando e mimando, miti esemplari, nei quali tutto si è già svolto nel modo desiderato. La negatività attuale del divenire viene così riassorbita in una “esemplarità mitica risolutiva”, viene cancellata in virtù di un come mitico, dove “il negativo è sempre cancellabile per la semplice ragione che è già stato cancellato”. 59 Destorificare significa dunque sospendere il divenire nella pura ripetizione del mito e del rito. Questa operazione ha un carattere soteriologico e reintegrativo, “reimmette l’esserci nella corrente positiva dell’operare” 60. La potenza della religione e dei suoi istituti sta nell’attuare la riconversione dalla paralisi della presenza all’operare umano nel mondo. La forza del sacro sta nel (ri)dischiudere all’uomo l’orizzonte del profano.
2.4 Il simbolismo mitico-rituale
Il tema del simbolismo mitico rituale, scandito dai tre momenti della crisi, del simbolo e della reintegrazione culturale, ci riporta nuovamente al tema della presenza, della sua perdita e della sua reintegrazione entro un orizzonte culturale determinato. L’apparato simbolico mitico-rituale assolve ad una molteplicità di funzioni: arresta l’alienazione della presenza individuale, difende dai rischi di recessione verso la inoperabilità del mondo, maschera la responsabilità umana della decisione operativa attuale e attenua l’imprevedibilità critica del futuro accadere. Il simbolismo mitico-rituale riassorbe la proliferazione del divenire e recupera la storia mediante la riproposizione di un mito delle origini. Il mito è sempre in qualche modo cosmogonia, narra come, in illo tempore, il mondo è stato fondato o creato. Il mito annuncia un evento che ha avuto luogo in un tempo aurorale, al di là della storia, e che costituisce un precedente esemplare per tutte le azioni e le situazioni che si presenteranno in futuro. Il rito ripete e rinnova il mito della fondazione, la sua iterazione è volta ad abolire il tempo profano e a ripresentare il mondo sempre di nuovo secondo la potenza esemplare della prima volta. 59
E.de Martino, Sud e Magia, cit., p.108 G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p.300
60
33
Il mito ‹‹[…] più che a sopprimere radicalmente il divenire è volto piuttosto a rendere mediatamente possibile il concedersi ad esso, il dischiudersi, sia pure a patto, alla storia. Certe sfere storiche della realtà sono dischiuse in quanto si entra in esse attraverso il nesso mitico-rituale in quanto cioè la loro storicità viene trasfigurata (in realtà permessa) attraverso la iterazione dell’identico (della prima volta, del mito delle origini)››. 61 Sebbene, a prima vista, possa sembrare che il mito operi così una definitiva abolizione della storia, in realtà, in quanto comportamento che ripete modelli metastorici, costituisce esso stesso un’azione e un comportamento storico, una iniziativa meramente umana di ripetizione. Il mito è, al tempo stesso, metastorico e cominciamento storico; ha luogo nella metastoria ma, d’altra parte, la sua metastoria ridischiude la storia umana, “la Einmaligkeit della decisione storica”. 62 In altre parole potremmo dire che “il tentativo di
uccidere la storia fa parte della storia e genera nuova storia”. 63
2.5 L’eter no r itor no nella cultura
Il simbolismo mitico-rituale e la ripetizione dei miti delle origini implicano una coscienza ciclica del tempo. La concezione ciclica del tempo si rivela un sistema protettivo volto a preservare la presenza dalla critica storicità del divenire umano. Il tempo ciclico è infatti il tempo della prevedibilità e della sicurezza; il suo modello è offerto dal ciclo astronomico e da quello delle stagioni: il suo modello appartiene di diritto alla natura. Trasferito sul piano umano, nell’ambito della storia, il tempo della prevedibilità e della sicurezza diventa il “tempo della pigrizia”, ovvero il rischio della stasi della presenza, del regresso dalla cultura alla natura. Se infatti in ambito naturale la ripetizione dell’identico si configura come regolarità e dunque “sta senza dramma” 64, nell’uomo significa invece il crollo della presenza e del mondo, coincide con l’istinto di morte, con
61
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p. 139 Id., p.225 63 Ibidem 64 Id., p.223 62
34
la paralisi dell’attività valorizzatrice. L’eterno ritorno, rigorosamente (cioè naturalmente) inteso, si profila dunque come un rischio estremo, come una radicale
insidia per la presenza umana nella storia. La ripetizione di un mito delle origini, l’iterazione della fo ndazione, sembra compiere ed esprimere una sorta di imitatio naturae, tuttavia tale imitatio non coincide con l’eterno ritorno che è proprio della natura. Nel simbolismo mitico-rituale l’eterno ritorno “naturale” viene riplasmato in una modalità del ripetere che appartiene in pieno al piano della cultura umana; viene cioè trasfigurato in un tipo di ripetizione che non si manifesta sua sponte ma che è in tutto e per tutto “sottomessa all’umana disciplina”.65
L’eterno ritorno del mitico-rituale è dunque una imitatio naturae che la cultura ha incorporato e riplasmato in un prodotto culturale, in una tecnica umana. È una modalità di ripetizione interamente piegata ai fini umani e che opera al fine di dischiudere la storia entro un regime protetto. ‹‹ Quando la nostalgia dell’identico si rende conto del vuoto che avanza, l’identità assume la forma dell’essere che si ripete, della nostalgia del divenire ciclico, a imitazione dell’ordine astronomico, della vicenda stagionale, della legge naturale. L’ordine simbolico assume questo rischio e mediatamente ridischiude l’impegno dell’esserci a trascendere le situazioni secondo valori culturali che l’uomo genera e che all’uomo sono destinati. […] L’ordine simbolico mitico -riturale rammemora periodicamente una origine assoluta della storia e un suo assoluto compimento, l’ordine simbolico ricorda l’origine e la prospettiva di un’epoca cui si partecipa›› . 66
2.6 La fine del mondo
L’iterazione dell’identico e la momentanea sospensione della storia che questa ripetizione implica generano la rappresentazione e l’esperienza di un ricominciare da capo, di un tornare-a, di una nascita che sempre si rinnova. La concezione del divenire ciclico della storia implica cioè il tema dell’eterna morte e dell’eterna rinascita del mondo, del suo perenne finire e risorgere. Tutte le rappresentazioni mitiche sono sorrette da questo sfondo. 65
G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri, P.Scarpi, Manuale di storia delle religioni , cit., p.531 E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p. 226
66
35
Il tema della fine del mondo è quel rischio antropologico permanente, proprio della presenza umana, trasferito sul piano simbolico. Il “finire” coincide con il rischio di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile. L’iterazione liturgica della fine e dell’inizio del mondo non fa che riproporre, in maniera metaforica e ritualizzata, il rischio della crisi della presenza, della sempre possibile caduta d ell’uomo dalla cultura al caos. La fine del mondo significa il rischio di perdere la possibilità di essere operativi nell’orizzonte mondano, implica “la catastrofe di qualsiasi progettazione comunitaria secondo valori”. 67 L’esorcismo contro questo rischio radicale è rappresentato dalla cultura umana, che lo fronteggia e lo riscatta. Il tema culturale della fine di un certo ordine mondano esistente costituisce una modalità storica di ripresa e di superamento del rischio. Un esempio dimostrativo, propostoci da de Martino al riguardo, è quello del rituale romano del Mundus.
2.7 Il rituale del Mundus
Mundus è una fossa a due piani, spazialmente situata al centro di Roma; la parte
inferiore è collegata al mondo degli inferi e dei defunti, quella superiore al mondo abitato e alla volta celeste. Il simbolo mundiale configura il cielo e la terra, il sopra e il sotto, concentra in sé lo spazio cosmico e culturale. Il mundus viene ritualmente aperto tre volte l’anno, in giornate nefaste. In questi tre giorni (segnati nel calendario con la dicitura mundus patet , cioè “il mondo è aperto”) i defunti vagano tra gli uomini, il caos regna sulla terra abitata, ogni attività viene sospesa. Mundus rappresenta il rischio di una caotica fine del mondo, della città, della cultura, di
tutti i suoi abitanti. È la ripetizione periodica della sempre possibile caduta collettiva nel caos. Questo rischio è presentificato e simboleggiato dal ritorno dei morti e dalla sospensione delle attività culturali, ma, allo stesso tempo, è controllato ed esorcizzato grazie alla sua fissazione e localizzazione in un determinato luogo e tempo. Il duplice simbolo spazio-temporale costituisce una reintegrazione e una risposta culturale. Il regresso al caos, il finire del mondo, non è dunque da temere poiché sarà succeduto da una rinascita, dall’inizio di un mondo nuovo. 67
Id., p.219 36
2.8 “L’ultimo giorno è sempre all’ordine del giorno”
68
L’angoscia per la fine del mondo è viva nell’uomo da sempre. Già presso la civiltà egizia e quella etrusca troviamo riflessioni di carattere escatologico e il pensiero della fine svolge un ruolo importante all’interno della cultura e delle dinamiche della società. Credenze e miti sulla fine del mondo sono presenti anche nello Zoroastrismo e nella religione degli antichi Maya; non mancano nemmeno in Oriente dove, presso l’Induismo e la dottrina Buddhista, rinveniamo la concezione di un cosmo che va ciclicamente incontro a deflagrazione e rigenerazione. La medesima concezione del tempo, inteso come un circolo di eterni ritorni e quindi di eterne distruzioni, vige nelle visioni del mondo dell’antica Grecia e di Roma. Il pensiero angoscioso per la fine del mondo costituisce un tema culturale non solo nel quadro delle periodiche distruzioni e rigenerazioni del mondo, e quindi nell’ambito delle configurazioni mitiche e dell’eterno ritorno, ma anche nel quadro di una storia caratterizzata da un corso unilineare e irreversibile. L’immagine dell’ordine mondano esistente che corre verso la fine non è dunque peculiare di una concezione ciclica del tempo, ma è propria anche di una storia umana che, a partire da una origine, muove verso il suo epilogo. La paura per il finire del mondo non è un derivato della teologia, non è un prodotto della religione o del mito, ma costituisce un tratto peculiare della natura umana, si rivela un carattere naturale per un animale privo di specializzazioni, come è l’uomo. L’angoscia per la fine del mondo non è dunque correlata a certi mondi culturali o a determinati sistemi sociali, ma semplicemente costituisce l’atteggiamento umano filogeneticamente più antico.
2.9 L’apocalittica cristiana
La tradizione giudaico-cristiana rompe con lo schema del tempo circolare, ma la coscienza mitico-rituale non risulta per questo annientata, penetra piuttosto nella stessa coscienza storica del divenire lineare e irreversibile. Se nelle grandi religione storiche, caratterizzate dal divenire ciclico del tempo, ad essere reiterato è il mito di fondazione e 68
Paolo Virno, Promemoria su Ernesto de Martino , in “Studi culturali”, Bologna, il Mulino,anno III, n.1, 2006 37
la esemplarità delle origini, ora la ripetizione degli inizi diventa ripetizione del centro, della morte e della risurrezione del Cristo. L’accento si spost a dalla ciclicità delle catastrofi all’attesa di un termine finale univoco: l’avvento del Regno di Dio. Con la profezia del Regno si passa da una fine del mondo prossima e imminente ad un suo rinvio, procrastinato nel tempo. Il rinvio della parusìa costituisce appunto l’operazione tecnica che consente la configurazione, e la dilatazione, di un orizzonte di operabilità mondana: l’attesa del Regno di Dio, ovvero l’attesa del mondo, porta con sé la nascita di un mondo. Lo spostamento della fine dalla imminenza alla lontananza, nonché la sua indeterminazione spaziale e temporale, permette una progressiva estensione dell’orizzonte lasciato alla operabilità del mondo.
Questo dispositivo di
“allontanamento” protegge e legittima l’azione umana, libera uno spazio da dedicare alle attività profane e alla pratica culturale della condivisione di valori. Il rischio della imminenza della fine viene riscattato dal Cristianesimo mediante la sua posticipazione; il finire viene mutato di segno e fatto coincidere con un nuovo cominciamento. Con questi espedienti, che dischiudendo la operabilità del mondo permettono il dispiegarsi di una vita culturale comunitaria, il Cristianesimo si rende fondatore di civiltà. Ma l’annunzio del Regno comporta anche alcuni rischi che sono incom patibili con l’attuarsi di una vita culturale comunitaria e che quindi minacciano la presenza umana: “verrà il tal giorno databile ed ora non c’è che da attenderlo con lo sguardo al cielo consumandosi in una esplorazione di segni”. 69 L’attesa della parusìa implica il rischio che l’uomo si ponga in una condizione di inerte aspettativa e che sospenda la sua azione, rendendosi inoperativo nel mondo e quindi inadatto al comportamento culturale. Il Cristianesimo si forma nella lotta contro questo rischio, la strategia che adopera al fine di scongiurarlo è quella di porre l’accento sul già: “Gesù è già venuto una volta e garantisce la seconda e definitiva; il Regno già comincia e si compirà; attraverso lo
69
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p.289 38
Spirito Santo e la Chiesa si compirà la promessa”. 70 Questo già non deve però essere concepito come attualità, come compimento già avvenuto 71, ma come un non ancora. ‹‹Ciò
che fece del Cristianesimo una religione fondatrice di civiltà, ciò che in esso
dischiuse la storia, fu appunto questa paradossale tensione fra già e non ancora , questo stare perennemente in tensione vigilante fra l'uno e l'altro, questo sentirsi garantito dal primo e sospinto verso il secondo, questo viversi di ciascuno nell’epoca dello Spirito Santo, della Chiesa, dell’apostolato, della testimonianza sino ai confini della terra, della buona novella da diffondere tra le genti in un rapporto dominato dall’agape. È appunto questa forma cristiana, storicamente definita, dell’ethos che regge il mondo. Ma questo ora fra già e il non ancora , se è la grandezza civile del Cristianesimo, costituisce anche
il suo travaglio: il già ora che oscura il non ancora e il non ancora che perde il già costituiscono due forze eccentriche che manifestavano il venir meno di quell’agape che Paolo poneva al di sopra della pistis e dell’elpís››. 72
2.10 L’eucarestia
L’esperienza della fine del mondo come rischio esistenziale antropologico tro va nella prospettiva del Regno -che è al tempo stesso attesa del futuro e promessa del passatoil suo orizzonte di reintegrazione. La catastrofe del crollo immediato e irrelato del mondo è riscattata e mutata di segno attraverso la prefigurazione del Regno di Dio e, più specificatamente, attraverso il rito eucaristico. L’eucarestia è la celebrazione ritualizzata, socializzata e istituzionalizzata dell’ultima cena, il banchetto del giorno estremo. Il rito dell’eucarestia presentifica il banchetto avvenuto nel passato e prefigura quello dei tempi estremi futuri: in virtù del simbolo eucaristico la comunità dei fedeli partecipa ad un orizzonte retrospettivo e prospettico. Proprio questo duplice orizzonte permette il dischiudersi della dimensione del presente (e della presenza nel mondo). ‹‹Il rischioso puntualizzarsi della catastrofe […] viene ora mediamente oltrepassato: con il Cristo il mondo ha cominciato a finire, in passato, nel punto centrale del piano divino 70
Id., p.288
71
Segnerebbe altrimenti la fine della testimonianza operativa mondama, al pari della inerte attesa.
72
Id., p.289
39
di salvezza; con il Cristo, sempre in passato, è stata data la promessa dei tempi estremi futuri; e infine con il Cristo reso presente nella iterazione del banchetto eucaristico, è possibile sperimentare nel qui e nell’ora non già l’attuale immediato crollare del mondo, ma la promessa passata e l’attesa futura del finire vivendo qu i ed ora non già i tempi estremi, ma la promessa del passato e l’attesa del futuro, e quindi la prefigurazione, l’anticipo, il pegno della seconda parusia che certamente avrà luogo, poiché già ha avuto luogo con la prima››.73 Con l’eucarestia si introduce nel tempo storico un rito periodico, limitato ad un determinato momento del calendario. In questo modo il tempo che intercorre tra le due celebrazioni è reso disponibile all’operare umano e alle attività culturali profane: tra il già e il non ancora l’esserci è libero di dispiegare la propria potenza.
Se fra il già e il non ancora del simbolo mitico-rituale cristiano la presenza può “prendere respiro”, la concentrazione calendariale periodica del comportamento liturgico libera il tempo per gli altri comportamenti culturali: ‹‹L’anno liturgico cristiano è un dispositivo culturale per la completa destorificazione del tempo: il Cristo vi è infinitamente ripetuto come una stessa voce in una caverna dominata dall’eco. E tuttavia il calendario delle celebrazioni se riassorbe in un anno metastorico gli anni storici del tempo, li ridischiude uno per uno, nei loro concretissimi mesi, giorni, ore e istanti, raggiungendo così quel decidere operativo secondo valori a cui l’uomo, f inchè è uomo, non può sottrarsi››.74
2.11 Apocalisse culturale
La fine dell’ordine mondano esistente è ciò che de Mar tino concettualizza col termine di “apocalisse culturale”. Questa nozione travalica il fenomeno religioso ed estende la vicenda dell’oscillazione tra il crollo e la ripresa della presenza ad ogni piano della vita umana. Potremmo dire che le apocalissi culturali “costituiscono l’ultima metamorfosi di quel dramma delle origini (la labilità del Dasein) che de Martino aveva intravisto per la prima volta nel magismo”.75
73
Id.,pp. 291-2 Id.,p.300 75 Paolo Virno, Promemoria su Ernesto de Martino, in ”Studi culturali”, cit. 74
40
L’apocalisse coincide con il dramma de lla perdita della presenza, esprime lo sprofondare di un ordine culturale, storico, psicologico: è perdere il mondo e perdersi nel mondo. Questa perdita accade su due fronti: si perde una patria, un luogo “domestico”, uno spazio di riconoscimento e, allo s tesso tempo, si oblia la propria tradizione culturale, la propria memoria del passato, e non si ha più un orizzonte temporale in cui poter operare. L’apocalisse è una catastrofe spaziale e temporale. La fine del mondo non implica necessariamente scenari di disastri cosmici o paesaggi catastrofici, ma è da intendersi come “il riflesso del disfacimento del nostro esserci”76, come la paralisi di una presenza che viene meno al compito di contrapporsi al mondo esterno e che si rivela drammaticamente incapace di emergere oltre la dimensione della natura. Nell’apocalisse il “movimento che trascende la situazione nel valore” 77, cioè il movimento che appartiene alla presenza, il suo ethos, subisce un arresto, uno scacco. Tuttavia nell’apocalisse culturale, così come concettualizzata da de Martino, è preminente il secondo termine della relazione: l’apocalisse culturale si caratterizza come tale per il fatto che la fine del mondo è assunta come un rischio incombente e non come una realtà di fatto. La presenza è alla fine reintegrata in quanto l’apocalisse culturale non ne occulta la crisi ma, al contrario, ne ripercorre ogni singola tappa e, proprio rivivendo tutti gli stadi della dissoluzione, è in grado di mutarne la direzione: il rischio della perdita è così, con successo, convertito in ripresa. La catastrofe dell’ordine mondano è una potenzialità negativa -che grava su tutte le culture umane- ma che mai diventa atto: il rischio è riscattato e superato nella reintegrazione culturale. L’apocalisse culturale non è dunque la fine del mondo ma la fine di un mondo. In tal senso l’apocalisse è naturale, è cioè un’esperienza connessa alla stessa storicità della condizione umana. La fine di un mondo, da ben distinguere dalla fine del mondo, rientra nell’ordine della storia culturale umana, fa parte della dimensione consueta dell’umanità. L’esperire il rischio della fine del mondo è un vissuto negativo che permette il dispiegarsi della vita stessa, è un momento indispensabile per poter essere padroni dei momenti che verranno.
76
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p. XXV E. de Martino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, cit., p.103
77
41
‹‹Le apocalissi (culturali) mostravano, in sè stesse, un volto bifronte e uno sguardo duplice. Da una parte guardavano alla loro catastrofe, al farsi passato del loro presente. Ma, per un’altra, guardavano nella direzione del futuro, a ciò che, attraverso la morte, rivela e afferma la sua nuova vita. L’attesa della fine, ossia il consapevole atteggiarsi di un’epoca nella forma della sua propria apocalisse, era anche attesa dell’inizio. E, fra l’una attesa e l’altra, la tensione era in sé stessa disposizione a che il nuovo si realizzasse››.78 Nelle apocalissi culturali il finire non significa una distruzione, ma coincide piuttosto con la concreta possibilità di una (ri)costruzione valorizzante, con un nuovo inizio.
2.12 Immagini di apocalissi culturali
La prima immagine di apocalisse culturale individuata da de Martino è quella proposta dalle grande religione storiche e dal loro apparato simbolico-rituale. Queste accolgono il tema della fine del mondo in quanto rischio periodico e ritualizzato. Grazie all ’orizzonte configurato dal mito, la fine viene vissuta collettivamente su un piano metastorico, ed è propedeutica alla genesi di un nuovo mondo storico. Un altro modello di risoluzione culturale della fine, che a bbiamo poc’anzi esposto, è quello costituito dall’apocalittica cristiana. La fine del mondo viene qui assunta come una possibilità sicura, ma indeterminata e lontana nel tempo. L ’operare umano, che si dispiega in linea retta tra un inizio e una fine certi, riacquista il suo pieno orizzonte: nell’attesa del regno di Dio l’uomo partecipa alla vita culturale della comunità. Altre immagini di apocalissi culturali ci vengon o offerte dall’escatologia del Terzo Mondo e dall’umanesimo marxiano. I movimenti di stampo apocalittico, presi in considerazione nell’ambito etnologico del Terzo M ondo, costituiscono la risposta alla traumatica esperienza dell’invasione coloniale occidentale. De Martino nota che in diverse zone dell’Africa e dell’Oceania il processo di decolonizzazione ha preso la forma di movimenti “chiliastici” nei quali il gruppo, sotto la guida di un leader carismatico, si preparava in vista di una imminente fine del mondo e dell’avvento di uno nuovo tempo. La tematica escatologica in questione attinge le 78
G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p. 334 42
proprie immagini da un lato dal patrimonio di credenze appartenenti alla tradizione, dall’altro impiegando gli insegnamenti neotestamentari diffusi dai missionari. L’apocalittica del Terzo Mondo si rivela così culturale (cioè opera un riscatto) trovando la soluzione alla crisi in un’azione di sincretismo tra vecchio e nuovo. Questa escatologia opera a favore della storicizzazione dell’esistenza, del passaggio dalla natura (ovvero dall’assenza di decisione sul proprio destino) alla cultura (all’iniziativa) individuando nella perdita del proprio ordine tradizionale la possibilità e la condizione per una reintegrazione in una dimensione umana più ampia e più matura. L’incontro etnografico, il confronto con il culturalmente alieno, non “uccide” una umanità, ma pone piuttosto le basi per un nuovo umanesimo . La fine del proprio mondo e del sistema di vita tradizionale viene così trasfigurata nel cominciamento di una nuova vita più completa: la “de-umanizzazione” viene convertita in una “ri -umanizzazione” del mondo. L’apocalisse marxiana non verte su una fine generalizzata del mondo, ma sulla fine del mondo di una determinata organizzazione sociale, economica e politica. Questa apocalittica trasferisce su un piano prettamente storico la dialettica fine/inizio. L’orientamento laico che la caratterizza costituisce la novità più importante del suo apporto e la rende differente da tutte le altre immagini di apocalissi culturali: per la prima volta siamo di fronte ad una apocalisse secolarizzata, che non rimanda ad alcun ordine o ideologia religiosa. In questo tipo di apocalisse il finire costituisce il preludio per il cominciamento di un nuovo modello storico, economico e sociale; il riscatto è rappresentato dal possibile raggiungimento di una società senza classi. De Martino individua nell’apocalisse marxiana il tipo positivo di una più generale apocalittica, o crisi, della società borghese contemporanea. L’apocalisse dell’Occidente, come è da lui definita, merita un discorso a sé stante che ci accingiamo ad affrontare.
2.13 L’apocalisse dell’Occidente
‹‹Il progresso della filosofia e della religione aveva fatto sì che, attraverso il Cristianesimo e il suo stesso “sacrificio”, l’umanità uscisse dalla fase della “protezione” religiosa. Ma la fine di questa non coincideva tuttavia con l’acquisto di una capac ità più
43
alta. […] Mentre le tradizionali barriere protettive cadevano sotto i colpi critici di una ragione fattasi adulta, l’umanità si trovava esposta al rischio […] di un nuovo dramma. Il rischio di non esserci che, […] ai tempi de Il mondo magico era stato confinato nell’area remota delle così dette civiltà primitive, e tenuto perciò ben lontano dalla securitas dell’Occidente maturo, si rivelava ormai appartenente anche a questa […].
Paradossalmente, era il progresso, era l’uscita dall’epoca delle protez ioni religiose, era il secolarizzarsi, […] a far nascere nell’anima occidentale un senso nuovo, epp ure antico, di timore e tremore››.79 Se nelle immagini di apocalissi culturali precedentemente descritte il tema della fine del mondo si risolve in una riplasmazione religiosa, e dunque si svolge lungo una dinamica che porta alla reintegrazione e al superamento culturale, l’apocalisse contemporanea esperisce invece la nuda crisi del finire alla sola polarità negativa. ‹‹ L’attuale congiuntura culturale dell’occidente conosce […] il tema della fine al di fuori di ogni orizzonte religioso di salvezza, e cioè come nuda e disperata presa di coscienza del mondano “finire”››.80 La crisi resta nuda quando si spoglia dell’orizzonte religioso, quando rompe con un piano teologico della storia, e con la direzione e il senso che da questo deriva. La disincantata autocoscienza occidentale, dopo aver perso Dio, e i simboli e i valori ad esso connessi, non riesce a trovare in se stessa quell’ “energia valorizzante” in grado di superare la crisi. Senza un orizzonte di reintegrazione, senza un luogo di protezione il finire non può essere preludio di un nuovo cominciamento o “anabasi verso un nuovo
ordine”81, ma viene piuttosto esperito al solo segno negativo, come tragica consapevolezza della catastrofe, come caduta negli inferi senza possibilità di ritorno. Siamo di fronte ad un disagio esistenziale generalizzato: la crisi borghese è una crisi di valori e pertanto porta con sé il rischio di perdere ogni possibile “patria c ultur ale”, ogni possibile mondo. La civiltà occidentale è vittima di una tentazione apocalittica e attraverso la sua produzione denuncia, con tutte le voci disponibili, la propria malattia: un male che sembra avere tutti i sintomi di una apocalisse senza escaton.
79
G. Sasso, Ernesto de Martino. Fra religione e filosofia , cit., p. 308 E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p. 467 81 Id.,p.471 80
44
2.14 L’apocalisse nell’arte contemporanea
La società borghese offre una molteplicità di documenti a testimonianza di questa radicale crisi: dalla letteratura alla filosofia, dall’arte alla musica, passando per il costume e la vita politica, emerge, in tutta la sua drammaticità, il sentimento tangibile della fine del mondo, l’avvertimento della catastrofe del mondano. L’analisi del “ pensiero della fine” nella letteratura, nella filosofia e nelle arti figurative evoca l’immagine di una “discesa agli inferi”, di un mondo che si sta sfaldando, di una patria che non è più riconosciuta dai suoi abitanti, di un significante che non ha più alcun significato: insomma di un cosmo che precipita nel caos. A parere di de Martino il documento dell’arte contemporanea ci permette di capire “quanto profonde siano le radici del male” e “quanto grave sia il pericolo della fine del mondo”82, per questo ne daremo un veloce e breve cenno. L’inferno irrompe nel mondo dell’arte contemporanea: se l’arte classica esibisce la proporzione, l’ordine e l’armonia umana, la nuova arte combatte contro ciò che è propriamente umano, e mostra l’inferno, la morte, il caos, eleva a materia del dipingere tutto ciò che non appartiene ai caratteri del l’uomo. Da Bosch a Brueghel, da Goya a Munch: l’arte rappresenta l’orrore, il mostruoso, il demoniaco, l’infernale. Se prima l’inferno era oggettivato nell’al di là e la sua irruzione in questo mondo era un evento temporaneo che tentava il santo o che possedeva lo scellerato, in Goya l’inferno diventa immanente nel mondo “inabita nell’uomo, l’uomo è demonizzato” e “sia l’uomo che il suo mondo sono esposti alle forze demoniache” 83. Il manicomio, le descrizioni di guerra e le tauromachie: tutti i temi di Goya mostrano la disumanizzazione dell’ uomo, (non più l’immagine di Dio), l’imbestiamento e il delirio delle masse.
2.15 Il pensiero della fine
‹‹ La lotta contro il “normale”, il “domestico”, il “familiare, l’ “abituale” caratterizza in modo eminente la congiuntura culturale moderna e contemporanea manifestandosi nell’arte, nella poesia, nella filosofia, nel costume. L’anormale, lo spaesato, l’estra neo, 82
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p.474 Id., p.486
83
45
il mostruoso, il gratuito senza senso attuale, il convenzionale e il meccanico stanno come argomento centrale della cultura in tutte le sue manifestazioni››.84 Il tema dell’apocalisse non pervade solo l’arte ma è caratteristico anche della filosofia, del teatro, della poesia, della narrativa, della sociologia e, con la teorizzazione freudiana dell’istinto di morte e della supremazia dell’inconscio, anche della psicologia. La medesima tematica è rinvenibile persino nella fisica dove la legge dell’entropia, la crisi del principio di causalità, il principio di indeterminazione e la relatività di Einstein ci riportano ad un mondo caotico, irrazionale, indistinto e confuso: tutto viene interpretato e letto nel quadro di una imminente apocalisse. Ma la tematica apocalittica domina, e si fa palese, soprattutto nella documentazione letteraria. De Martino segnala una grande varietà di opere incentrate sul problematico rapporto tra l’io e il mondo, tra l’io e gli altri, tra soggetto e oggetto; tutti questi documenti letterari risultano essere variamente pervasi, se non ossessionati, dal pensiero della fine.
Dalla “nausea” di Sartre, all’”assurdo” di Camus e di Beckett, da Kafka alla “malattia degli oggetti” e alla “noia” di Moravia: quello che si evince è la preoccupante diffusione di un malessere esistenziale profondo e generale, di un sintomo di crisi che ha contagiato la intera civiltà occidentale. La crisi della presenza che si sviluppa in questo periodo manifesta dei caratteri totalmente inediti; le opere letterarie vengono valutate da de Martino “ora come sintomi di una malattia, ora come conati di reintegrazione, ora come documenti clinici” 85 e l’analisi porta alla diagnosi di un morbo culturale diffuso quanto pericoloso. È soprattutto nell’opera di Sartre 86 che emerge il sentimento di spaesamento e di “crisi della patria culturale” che caratterizza l’odierna civiltà occidentale e che porta inevitabilmente al “minaccioso restringersi di qualsiasi orizzonte di un futuro operabile comunitariamente secondo umana libertà e dignità”. 87
84
Id., pp.474-5 Id.,p.466 86 Jean-Paul Sartre (1905-1980) scrittore e filosofo francese, l’opera cui facciamo riferimento è La Nausée, pubblicata nel 1938 87 Id.,p.479 85
46
Scrive de Martino commentando Sartre: ‹‹La nausea è il rischio della nuda esistenza, spogliata della presentificazione valorizzante umana, di tutte le memorie operative della cultura, di tutti i nomi evocanti queste memorie, di tutti gli abiti che rendono familiare il mondo: è quindi il rischio del nulla, della fine del mondo, dell’annientarsi di qualsiasi margine rispetto al mondo››.88
2.16 L’apocalisse senza escaton
Nella società del capitalismo maturo, nell’età della tecnica totalmente dispie gata, si avverte tangibilmente ‹‹l’idoleggiamento del contingente, del privo di senso, del mero possibile, del relativo, dell’irrelato, dell’irriflesso, dell’immediatamente vissuto, dell’incomunicabile, del solipsistico››.89 La “disposizione annientatrice” insita nella società borghese trova “il suo infausto coronamento nel terrore atomico della fine, cioè nella prospettata possibilità che l’umanità si autodistrugga” 90. Il rischio concreto e catastrofico di una guerra nucleare costituisce allo stesso tempo la realtà e il simbolo di una società che può totalmente e irreversibilmente perdersi. A differenza di tutte le altre apocalissi culturali, l’apocalisse dell’Occidente non realizza in sé stessa il suo proprio superamento, non è orientata nella direzione del futuro e del valore, ma svolge piuttosto un’oper azione di carattere distruttivo, di annientamento. L’apocalisse che caratterizza questo tempo è cioè una apocalisse culturale anomala, una apocalisse che presenta la sola faccia del disastro. La “crisi della presenza” (cioè la “fine del mondo”) non si verifica più in momenti critici o in circostanze eccezionali ma sembra aver assunto, oggi, un carattere permanente. Non si tratta più di un episodio ciclico od occasionale, ma di un evento che pervade la quotidianità, che impregna l’ordinario, di una situazione che si fa routine, drammatica abitudine. Nell’apocalittica del presente non c’è discernibilità tra polo della crisi e polo del riscatto: “la crisi è già ripetizione e la ripetizione non si discosta realmente dalla crisi” 91, 88
Id.,p.529 Id.,pp.471-2 90 Id.,p.468 91 Paolo Virno, Promemoria su Ernesto de Martino, in ”Studi culturali”,cit. 89
47
per così dire, l’altalena della presenza non si stabilizza. La presenza diventa anzi quello stesso moto oscillatorio e non perviene ad una risoluzione stabile, non trova l’equilibrio per l’azione (o per il discorso) culturale. L’apocalisse non attinge cioè al suo termine: quello di ricostituire pienamente la presenza (e, con essa, il mondo). L’apocalisse dell’Occidente è pervasiva, ubiqua e perenne, ma non si chiude. Incapace di far finire la fine in nuovo inizio si rivela priva di una interna energia di riscatto, si rivela cioè priva di escaton ,e pertanto, inconclusiva. La mancata prospettiva di una reintegrazione culturale e il finire vissuto come catastrofe in atto rendono l’apocalisse dell’Occidente pericolosamente analoga a quella psicopatologica. Proprio per tale allarmante contiguità “l’apocalisse senza escaton” si presta, in modo elettivo, ad innestare un prolifico confronto tra apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche, altresì rivelando il valore euristico di quest’ultime.
2.17
Apocalissi
psicopatologiche
e
apocalissi
culturali:
confrontare
per
differenziare
Nell’ottica di de Martino, le strategie culturali di resistenza possono essere adeguatamente comprese e proficuamente recepite solo alla luce del confronto con le crisi prive di riscatto appartenenti all’ambito della psicopatologia. Il ricorso al documento psicopatologico si rivela dunque uno strumento di fondamentale importanza per illustrare la genesi e il funzionamento dei dispositivi reintegrativi culturali, magici e religiosi. La psicopatologia accede all’universo della crisi in atto, le cui molteplici manifestazioni forniscono “la materia su cui si modellano le tecniche religiose di destorificazione e di reintegrazione”92. Presentando il rischio -della crisi della presenza e della fine del mondo- nella sua forma più estrema ed esasperata, il dato psico patologico risalta ‹‹ per forza di contrasto e per opposizione polare quelle reintegrazioni culturali, quei simboli variamente religiosi, che hanno combattuto questo rischio››.93
92
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p. XVI Id.,p.15
93
48
De Martino qualifica i due tipi di forme apocalittiche proprio mettendole l’una di fronte all’altra, intendendole per contrasto, identificandole mediante (e nella) loro differenza. Analizzando le analogie che intercorrono tra i due tipi di apocalisse mira a farne risaltare le fondamentali differenze di sostanza, i differenti esiti, il dinamismo di direzione opposta che le caratterizza: ‹‹Chi sale e chi scende una rampa di scale si incontrano necessariamente su un certo gradino: ma quel loro incontrarsi non significa che, nel momento in cui poggiano il piede sullo stesso gradino, le istantanee relative della loro identica posizione hanno lo stesso significato dinamico, poiché l’uno sale 94 e l’altro scende››.95 Il confronto non si riduce dunque alla mera registrazione dei punti di convergenza (che pure sussistono) ma tende piuttosto a far emergere, con nitore, le divergenze e i criteri discriminanti che consentono di distinguere le due formazioni apocalittiche. Usando il linguaggio di de Martino potremmo dire che, con l’uso sapiente del documento psicopatologico, si utilizza il morboso per rischiarare il processo del farsi sano, o che si comprende il sano nel suo “farsi sano oltre il rischio dell’ammalarsi”. Tuttavia lo studioso ci tiene a specificare che non si tratta di “spiegare il sano con il malato”, piuttosto di mostrare come le apocalissi culturali costituiscano -o possano costituire- il rimedio terapeutico, la medicina omeopatica contro il rischio della nuda crisi psicopatologica.
2.18 La fine del mondo come esperienza psicopatologica
Il vissuto della fine del mondo che appartiene alla fisiologia di una vita culturale riprende e reintegra il rischio della fine secondo valori intersoggettivi e comunicabili. Ma quando gli orizzonti culturali vengono a mancare e il rischio resta un vissuto privato e incomunicabile ci troviamo nella sfera della psicopatologia individuale, della fine del mondo come patologia di una data biografia, di un determinato individuo. L’analisi concernente i vissuti di fine del mondo in ambito psicopatologico ha il valore metodologico di mettere in evidenza quel rischio antropologico permanente -il rischio 94
Mentre nelle apocalissi culturali il rischio sta come momento di una dinamica di ripresa e di reintegrazione, e quindi si “sale il gradino” perché opera il riscatto, nella malattia psichica il rischio resta nudo, senza ripresa e reintegrazione efficaci, e dunque si “scende”. 95 Id.,p.63 49
di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile- nella sua forma più acerba, priva di una qualsivoglia elaborazione culturale e storica, e dunque priva di reintegrazione e di ripresa. Nel “delirio di fine del mondo” il malato esperisce come prossima a sé una catastrofe apocalittica dalle dimensioni cosmiche: l’orizzonte mondano si destruttura, la catastrofe coinvolge tutti gli ambiti percettivi, irreversibilmente crolla quello sfondo di ovvietà e di domesticità delle cose che permette la progettazione comunitaria dell’utilizzabile. Quello che de Martino vuole qui presentare è la fine del mondo non più come figura culturale, ma come bruciante, tragica, esperienza vissuta. La fine come esperienza psicopatologica, l’apocalisse come tema delirante, rappresenta infatti una sorta di “grado zero” dell’esistenza, costituisce la nitida immagine della nuda crisi, del rischio della presenza nella sua forma più cruda ed essenziale. ‹‹ Nel vissuto della fine ciò che finisce è, innanzitutto, il significante, l’operabile secondo valori, la progettazione comunitaria intersoggettiva e comunicabile, la potenza dell’andar sempre oltre rispetto alla situazione emergendo come esistenza operante e progettante, aperta alla valorizzazione, alla intersoggettività e alla comunicazione. Questo finire […] si dispiega come crollo della stessa energia del definire su tutto il fronte della possibile valorizzazione››.96
2.19 La crisi della presenza nella psicopatologia: derealizzazione e depersonalizzazione
Ciò che crolla con la fine del mondo è lo stesso esserci; il finire dell’ordine mondano significa infatti il venir meno della presenza come agire e la caduta della capacità umana di trascendere. Vivere la fine del mondo coincide col vivere la catastrofe della propria presenza, la fine del proprio sé, del dispiegarsi della propria attività in un mondo sociale, culturale e storico. Se non si agisce si è agiti, se la presenza è in crisi si esperisce l’alienazione: l’esse reagito-da (il Gemachtsein) e la radicale estraneità di ciò da cui si è agiti sono i due momenti che caratterizzano il vissuto di alienazione. Quando una presenza è alienata il 96
Id.,p.86 50
sé si estranea da sé, si perde il sentimento dell’io, si verifica uno “spossessamento del pensare, del volere, del sentire” 97, un diventar tutt’altro delle funzioni psichiche, “n on soltanto il divenire mondano perde la sua fluidità, progettabilità e operabilità, ma lo stesso divenire psichico è vissuto in atto di incepparsi”. 98 Nell’ampio quadro del vissuto di alienazione rientrano molteplici psicopatologie, che riflettono tutte la crisi della presenza alla sua sola polarità negativa : dalla derealizzazione e dalla depersonalizzazione alle psicosi maniaco-depressive, dalle fobie alle schizofrenie. Se nel delirio di fine del mondo la incombente minaccia apocalittica grava su tutti gli oggetti ed enti intramondani, e quindi riguarda il mondo esterno, nella derealizzazione e nella depersonalizzazione ad essere annientato è il proprio corpo, la propria persona; abdica la stessa presenza e la sua energia presentificante. Nella depersonalizzazione si perde il proprio ego, si esperisce un senso di estraneità nei confronti dei propri processi mentali, dei propri atti, delle proprie azioni e percezioni: l’io diventa estraneo a se stesso, il soggetto è disancorato da sé. Anche il proprio corpo viene avvertito come distaccato, come non proprio e non familiare; gli oggetti del mondo esterno si rivelano parimenti estranei e irreali, come se fossero percepiti da qualcun altro. Nella derealizzazione il mondo esterno appare privato del carattere di realtà e di “coloritura affettiva”, anche gli ambienti più familiari sono avvertiti co me estranei, lontani e irreali. L’io derealizzato non riconosce la propria identità, si sente fuori dalla realtà e non appartenente a ciò che dice e a ciò che fa. Nella derealizzazione e nella depersonalizzazione a crollare non è il mondo, ma l’esserci nel mondo, il mondo in quanto “mio”. Quando viene a mancare il rapport o simpatetico fondamentale tra uomo e mondo, -rapporto che precede ogni conoscere ed ogni volere e che costituisce la base di tutti gli atti cognitivi ed operativi-, la presenza non può dispiegare la propria attività, non può esserci.
97
Id.,p.74 Ibidem
98
51
2.20 Catatonia e destorificazione irrelativa
Ogni momento del divenire è nuovo, e quindi critico per la presenza. L’angoscia del divenire costituisce un vissuto psicopatologico che coinvolge tutti i momenti del divenire stesso, indipendentemente dal loro contenuto. La difesa estrema da questa angoscia è costituita dal rifiuto di ogni rapporto con il mondo e dalla totale passività psicomotoria: ovvero dallo stato della catatonia. Il rischio di non mantenersi come presenza nel divenire e di essere travolto dal flusso storico delle situazioni, si esprime nella difesa estrema del catatonico, che tenta disperatamente di ridurre il divenire alla permanenza dell’essere (ad esempio praticando la flessibilità cerea, l’imitazione speculare o la stereotipia) 99. Lo stato catatonico genera una paradossia: il sistematico rifiuto di ogni rapporto col mondo lascia trasparire un rifiutare che è ancora, inevitabilmente, immerso nel mondo. Vale a dire, lo stesso rifiuto sistematico del divenire è inserito nel divenire, e a suo modo diviene. Il rifiuto di qualsiasi rapporto con la realtà e la negazione del divenire messa in atto dal catatonico costituiscono un esempio di “cattiva” destorificazione, una forma di difesa non compatibile con la civiltà, ma attinente all’ambito della psicopatologia. Nella destorificazione socializzata ed istituzionalizzata, dunque nella destorificazione che costituisce a tutti gli effetti una valida e fisiologica forma di difesa culturale, ad essere “critici” sono solo alcuni momenti del divenire, e non il divenire nella sua totalità. Questa modalità di destorificazione permette di lasciare libere, cioè profanamente operabili, le altre parti di storia; la negazione del divenire non si rivela così una sua soppressione radicale, ma piuttosto un modo di rendere mediatamente possibile il concedersi al divenire stesso, “il dischiudersi, sia pure a patto, alla storia”. 100 La difesa estrema del catatonico invece non alcun carattere culturale, non è “sana” in quanto il rischio non è socializzato ma esperito unicamente dal singolo individuo. Inoltre l’angoscia per il divenire non è circoscritta a determinati segmenti del tempo, non è superata con il ricorso alla memoria retrospettiva collettiva e ai dispositivi 99
La flessibilità cerea consiste nell’assunzione di una determinata posizione del corpo che viene mantenuta anche per lunghissimo tempo, si tratta di una sorta di “negativismo fisico”. La stereotipia può essere cinetica o verbale e consiste nella rigida ripetizione di un gesto o di parola, senza alcuno scopo o funzione apparente. 100 Id.,p.139 52
difensivi forniti dalla tradizione culturale: anziché aprire il cammino verso il futuro, questo tipo di occultamento della storia segnala un regresso, una perdita senza compenso. La destorificazione operata dal catatonico presenta dunque tutti i caratteri della patologia: non è socialmente disciplinata, non è sorretta da un orizzonte culturale, cioè non è istituzionalizzata, ma è piuttosto una insorgenza spontanea e totalmente incontrollata del singolo individuo. La negazione del divenire perseguita dal catatonico si rivela una destorificazione irrelativa, un conato che, rimanendo imprigionato nell’incomunicabilità di un singolo e internato nell’individualità di una psiche, non può trovare ri-soluzione.
2.21 Schizofrenia e mentalità primitiva
Proseguendo con il confronto tra apocalissi psicopatologiche e apocalissi culturali, de Martino recupera da Alfred Storch 101 una significativa comparazione tra le caratteristiche appartenenti allo schizofrenico e quelle tipiche della mentalità primitiva. La “legge di partecipazione”, per cui è possibile essere una persona e contemporaneamente un’altra, la non validità del principio di identità e di non contraddizione e del principio di causalità sono tutte caratteristiche che abbiamo visto essere presenti nella cosiddetta “mentalità prelogica” dei primitivi 102, e che ritroviamo, praticamente inalterate, nella mentalità dello schizofrenico. Per il primitivo, come per lo schizofrenico, l’identità personale non è incompatibile con una dualità o una pluralità di persone; l’io è estremamente labile, la presenza è incerta e precaria, e i confini tra soggetto e mondo non sono definiti. L’autonomia del primitivo, così come quella dello schizofrenico, è continuamente minacciata dal mondo esterno, è sempre rimessa in questione: tutti gli eventi diventano profondamente significativi in quanto contribuiscono a sostenere l’essere della persona o a insidiarlo pericolosamente. Entrambe le tipologie di individui vivono una crisi di
101
Alfred Storch (1888-1962) psichiatra tedesco che, servendosi di un’analisi analitico-esistenziale, indagò gli stadi iniziali della schizofrenia. 102 Così come è stata teorizzata da Levy-Bruhl. 53
oggettivazione: non hanno cioè la capacità di rappresentare, di “gettare davanti” a sé l’oggetto, ma ne sono piuttosto invasi, posseduti. Il primitivo e il soggetto schizofrenico non vivono in un mondo “sicuro” : per dirla con Laing103, la loro condizione esistenziale è quella di una insicurezza ontologica primaria . Se tutto costituisce una minaccia per la propria esistenza, l’individuo – schizofrenico e primitivo- deve continuamente escogitare dei modi per mantenersi vivo e presente, per conservare la propria identità: deve cioè lavorare continuamente per impedire a se stesso di perdersi. Ma soltanto uno di loro riesce ad “assicurarsi” l’integrità della propria presenza. Il mondo magico del primitivo è un mondo culturale, caratterizzato da uno sfondo di attività comune e di reciproca comprensione linguistica: qui il magico è opera collettiva innestata nel mondo dello stare insieme. L’uomo primitivo è dunque un essere sociale, immerso in una civiltà e partecipe di una determinata tradizione. Egli interagisce attivamente coi membri della comunità, ha alle spalle una memoria collettiva che sostiene ed orienta i suoi comportamenti: il primitivo è sotto la protezione dello stare insieme, del Miteinender . La sfera del Miteinender , dell’agire e dello stare insieme, è invece la grande assente del mondo schizofrenico. Lo schizofrenico è gettato fuori dall’ essere-con, vive nella chiusura dell’isolamento e nell’incomunicabilità. Il mondo c’è solo per lui, non per gli altri, il mondo non segue dalla storica continuità col passato ma e merge da un “mutato trovarsi”: ‹‹la esistenza strappata dalla sua continuità storica, derubata dal suo stare insieme, è esposta senza protezione alle scosse delle situazioni limite››.104
103
Ronald D. Laing (1927-1989). Il concetto sopracitato di “insicurezza ontologica primaria” è trattato nel terzo capitolo dell’opera “L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale” (1960) 104 Id.,p.44 54
III. LE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE DELLA CRISI DELLA PRESENZA
‹‹Il linguaggio è la casa dell’essere e nella sua dimora abita l’uomo››. Martin Heidegger
L’uomo si differenzia dalle altre specie animali per la sua proprietà di linguaggio. Il discorso verbale è parte integrante della nostra costituzione biologica: l’uomo è un animale parlante . L’esserci si caratterizza e si qualifica per la sua facoltà di linguaggio,
per l’enunciazione di atti di parola. Una presenza è tale quando agisce nel mondo (difatti è in crisi quando è “agita-da”), e, come ci ricorda anche Wittgenstein, “le parole sono azioni”: il linguaggio è una attività. Ogni enunciazione, ripercorrendo le tappe dell’antropogenesi, fonda e ricostituisce la presenza umana nel mondo. Se l’esserci si identifica col linguaggio, se il linguaggio è la casa dell’essere , ne consegue che una presenza in crisi non può non riportare conseguenze sul piano linguistico -piano per definizione appartenente all’ontologia e alla biologia umana. Se essere presenti coincide con l’essere in grado di eseguire atti linguistici, ecco che la crisi della presenza significa la paralisi di questa naturale attività umana, l’anomalia della discorsività linguistica: l’eccesso o il difetto di semanticità.
55
3.1 Afasia della contiguità
Un discorso si sviluppa secondo due differenti direttrici semantiche: un tema conduce ad un altro sia per similarità sia per contiguità. Nell’afasia l’uno o l’altro di questi due processi è fortemente indebolito o completamente bloccato. La deficienza nella strutturazione del contesto è tipica di un disturbo che potremmo definire come disturbo della contiguità. Questo tipo di afasia altera la facoltà di costruire proposizioni, cioè di combinare unità linguistiche più semplici in unità più complesse, determinando pertanto una riduzione della lunghezza e della varietà delle frasi. Non c’è una perdita totale delle parole, ma anzi la parola è la sola entità linguistica a rimanere integralmente intatta. Ad essere abolita è piuttosto la gerarchia delle unità linguistiche, i loro legami di coordinazione e di subordinazione, di accordo e di reggenza. Le parole che dipendono grammaticalmente dal contesto sono le prime ad essere dissolte: spariscono le congiunzioni, le proposizioni, i pronomi e gli articoli; resiste invece il soggetto, la “parola nucleo”. Caratteristica di questo disturbo della contiguità è la soppressione della flessione: così appare l’infinito in luogo delle diverse forme verbali finite, il nominativo al posto di tutti gli altri casi. Analogamente vi sarà una tendenza ad omettere le parole derivate dalla stessa radice: “grande, grandezza, grandioso” saranno semanticamente congiunte per contiguità. Il malato conserva solo un’immagine integrale e indissolubile di ogni parola familiare, tutte le altre sequenze foniche, o gli appaiono estranee ed oscure, oppure le ingloba in parole familiari, ignorando le deviazioni fonetiche. La regressione del sistema fonematico comporta un’inflazione di omonimi e un impoverimento de l vocabolario; tale regressione è graduale e ci presenta, al processo inverso, l’ordine delle acquisizione fonematiche del bambino: è come se il malato regredisse alle fasi iniziali dello sviluppo linguistico infantile. Nei casi più avanzati l’incapacità fonematica e lessicale si accentua ulteriormente, fino ad arrivare a far coincidere la parola con un unico fonema. Quando l’ultimo livello ad essere conservato è quello distintivo del fonema, la separazione tra le due funzioni del linguaggio (l’una distintiva e l’altra significativa) è dissipata: la parola perde la sua
56
funzione e il suo valore significativo, il soggetto dimostra un deficit nella propria capacità semantica, esibisce cioè un difetto di semanticità.
3.2 Afasia della similarità
Mentre nel disturbo della contiguità la funzione contestualizzante è gravemente compromessa, e dunque il processo di formazione del contesto disintegrato, nel disturbo della similarità, al contrario, il contesto costituisce il fattore indispensabile e decisivo, mentre la deficienza riguarda le capacità e le operazioni di selezione e di sostituzione (che invece persistevano nell’opposto disturbo). Per un afasico di questo tipo quanto più il discorso è inserito nel contesto, e quanto più le espressioni dipendono da esso, tanto più avrà successo nel suo compito verbale. Egli non è in grado di formulare una frase che non risponda alla replica di un interlocutore o all’effettiva situazione del momento: il suo discorso è un fatto essenzialmente reattivo; l’espressione “piove” non può es sere realizzata se il soggetto non vede che fuori piove realmente. Posto di fronte a frammenti di parole o di frasi li completa facilmente, ma risulta particolarmente difficile, per il malato di questo disturbo, iniziare un dialogo, così come formulare o comprendere un discorso chiuso come il monologo. Le frasi sono concepite “come sequenze ellittiche che si completano da frasi precedentemente dette, oppure immaginate, dall’afasico stesso, o da lui ricevute da parte di un interlocutore reale o immaginario”.105 Le parole che comportano un preciso riferimento al contesto, come i pronomi e gli avverbi pronominali, e quelle che dipendono dalle altre parole della frase, come le congiunzioni e gli ausiliari, si mantengono saldamente e sono stabili, mentre l’agente principale, cioè il soggetto, tende ad essere omesso. Un afasico che soffre del disturbo della similarità, partendo da una parola non riesce a passare ai suoi sinonimi né ai suoi eteronimi, o alle equivalenti circonlocuzioni: la sua funzione sostitutiva è gravemente danneggiata. Analogamente se qualcuno gli indica un oggetto, egli non sarà in grado di dire il nome dell’oggetto indicato: se un segno è già 105
Roman Jakobson, Saggi di linguistica generale , Feltrinelli, 2008, pp.29-30 57
stato usato da qualcuno, l’altro segno (il suo sinonimo) gli appare infatti ridondante e superfluo e pertanto lo eviterà; invece di dire “questa è chiamata matita” aggiungerà piuttosto un’osservazione sul suo uso, come “serve a scrivere”. Anche la semplice iterazione di una parola pronunciata dall’esaminatore sembra al malato del tutto inutile e ridondante, perciò sarà incapace di ripeterla. L’afasico ha perso la capacità di “commutare il codice”, pertanto il suo modo di parlare diventa la sola realtà linguistica da lui riconosciuta e compresa, mentre il discorso dell’altro gli appare formulato in una lingua sconosciuta. In altre parole all’afasico ciò che manca è il metalinguaggio, necessario per il funzionamento ordinario del linguaggio, oltre che per il suo processo di acquisizione. La carenza afasica della capacità di denominare costituisce proprio il riflesso della perdita del metalinguaggio e dell’incapacità di ricorrere ad esso. In tali condizioni in cui è alterata la funzione sostitutiva, mentre rimane intatta quella contestuale, tutte le operazioni che implicano similarità cederanno a favore di quelle basate sulla contiguità. Ogni raggruppamento semantico sarà cioè guidato dalla contiguità spaziale o temporale piuttosto che dalla similarità. La capacità semantica del soggetto risulta ridotta in tale direzione.
3.3 Linguaggio e crisi della presenza nella schizofrenia
Per poter avere un rapporto da essere umano con un’altra persona, per poter interagire con un altro-da-me, è necessario un solido senso della propria identità e della propria autonomia. Se così non è, ogni rapporto con l’altro costituisce una minaccia per l’esserci, e il rischio di perdere la propria presenza. L’io dello schizofrenico, che abbiamo visto essere una formazione particolarmente incerta e precaria, non riesce a sostenere un confronto (fisico o verbale) con altre presenze senza esserne ontologicamente turbato. Per questo lo schizofrenico si isola, vive immerso in un mondo tutto suo, un mondo diverso e incomunicabile. Lo schizofrenico vive nel terrore costante di essere com-preso: essere capito, parlare lo stesso linguaggio, significano per lui essere risucchiato, essere inghiottito, essere
58
fagocitato dall’altro, per l’appunto essere “com- preso”: preso-con l’altro, e quindi “ perso”. L’incertezza e la precarietà che caratterizzano il suo esserci comportano dunque delle rilevanti ripercussioni sul piano linguistico: la crisi della presenza esperita dallo schizofrenico si riflette in dei deficit del linguaggio, in delle anomalie linguistiche, e in delle “alterazioni di semanticità”. Un soggetto schizofrenico comprende senza problemi il significato letterale di un enunciato, ma ha difficoltà a capire le intenzioni del soggetto parlante: quando, ai fini della validità e dell’efficacia della comunicazione, c’è da tenere conto della conos cenza e delle intenzioni del parlante, il locutore schizofrenico puntualmente fallisce nella comunicazione. I problemi emergono dunque sugli aspetti espressivi del linguaggio, piuttosto che su quelli ricettivi. La componente sintattica è mantenuta intatta, le frasi costruite dallo schizofrenico sono linearmente ben collegate tra di loro, ma manca una corretta connessione tra di esse, manca cioè il senso e la coerenza del discorso. Senso e coerenza sono infatti componenti che la sola capacità grammaticale non è in grado di apportare al discorso, ma per le quali è necessario un bagaglio di conoscenze extralinguistiche, una conoscenza del contesto in cui si parla: una pragmatica.
3.4 Il deragliamento linguistico
Questa anomalia, per cui le frasi sono linearmente correlate ma malamente connesse al nucleo centrale del discorso, viene conosciuta come i l “fenomeno del deragliamento”. Gli schizofrenici non sono in grado di fornire una descrizione e/o una narrazione compatta e coerente, senza includere nel discorso parole inappropriate, inusuali e devianti, senza perdersi in frasi inadeguate e superflue, malamente collegate tra di loro. Il locutore schizofrenico si rende conto che l’ascoltatore ha bisogno di maggiori informazioni per comprendere il proprio discorso, ma risulta ugualmente incapace di comprendere quali informazioni vadano fornite. Nel deragliamento le idee e le parole deviano in una direzione non apparentemente collegata con il concetto di partenza.
59
Il soggetto schizofrenico, sprovvisto delle “norme sociali convenzionali”, utilizza dei rimandi che non sono socialmente riconosciuti, ma che appartengono al suo solo mondo, e che quindi hanno senso solo per lui. Il significato è infatti una nozione collettiva e pubblica, che implica una fruibilità transindividuale e una comprensione intersoggettiva. Adottando le parole di Wittgenstein, lo schizofrenico parla un “linguaggio privato” che, proprio in virtù di tale caratteristica, non può considerarsi un vero linguaggio (sociale e pubblico per definizione). Nei casi più gravi il discorso dello schizofrenico può essere così fortemente disorganizzato e incoerente da risultare quasi incomprensibile: si parla in questo caso di schizofasia, ovvero di una disgregazione radicale del linguaggio e di una estrema
dissociazione semantica in luogo della quale l’eloquio viene sostituito da una “insalata di parole” prive di significato. Secondo Frith106 il fenomeno del deragliamento riflette un deficit dell’autocontrollo delle intenzioni del parlante, un venir meno dell’intenzionalità, e di conseg uenza della progettazione, del soggetto, della presenza. Sembra che lo schizofrenico, piuttosto che agire il discorso ed esserne il centro, si lasci agire da esso. L’incapacità di comprendere
le altrui intenzioni, e quindi di assumere socialmente il ruolo dell’altro, la mancanza di autocontrollo e la perdita di intenzionalità sono manifestazioni linguistiche che riflettono la crisi della presenza di cui il soggetto schizofrenico è vittima.
3.5 Le parole come cose
Un’altra anomalia linguistica appartenente alla sintomatologia schizofrenica è la tendenza a trattare le parole come cose. Nella schizofrenia vi è un predominio del materiale verbale su quello oggettuale; tale predominio, per cui lo schizofrenico attua uno slittamento tra parole e cose, si manifesta in più modi. Nella schizofrenia infatti le parole sono trattate come cose in sensi diversi: nel senso che vengono prediletti i significati concreti e letterali dei termini, nel senso che le parole si traducono immediatamente in fatti, e nel senso che il piano del linguaggio è scollegato dal mondo e costituisce una realtà a sè stante.
106
Il testo cui facciamo riferimento è “Neuropsicologia cognitiva della schizofrenia” (1995) di Christopher Frith. 60
L’apparente astrattezza del linguaggio schizofrenico, in realtà, non è che la conseguenza del fatto che il soggetto schizofrenico intende le parole in maniera radicalmente letterale, e dunque opera ad un livello estremamente concreto. Usando la locuzione “le forze dell’espressione dei sentimenti di odio e di amore” per designare gli “artisti”, lo schizofrenico non si serve di un astrattismo, ma opera piuttosto una restrizione dell’alone semantico delle parole. Questa formulazione normalmente non designerebbe soltanto gli artisti, (poiché possiede infatti un alone semantico molto più vasto), ma l’uso che ne fa lo schizofrenico rende l’espressione molto più concreta e ristretta. Il linguaggio dello schizofrenico sembra astratto ma in realtà si svolge ad un livello astrattivo inferiore: usando termini astratti come se fossero concreti, gli schizofrenici operano un restringimento del campo semantico delle parole, presentano cioè un difetto di semanticità.
3.6 Devianza semantica e neologismi
Per questa tendenza a trattare le parole come cose, lo schizofrenico non riesce ad andare oltre il significato letterale dei termini, non riesce cioè a comprendere gli enunciati metaforici. La metafora infatti è una violazione di regole all’interno di un dato contesto, è “intenzionalmente sgrammaticata”. Lo schizofrenico, incapace di comprendere le intenzioni e il contesto extralinguistico, non coglie il significato delle metafore e le interpreta letteralmente: tende cioè a preferire i significati denotativi, che si riferiscono immediatamente al referente, rispetto a quelli connotativi, più lontani dal referente immediato. 107 Si potrebbe dire che gli schizofrenici “evitano un uso del linguaggio che si riferisca a qualsiasi cosa che si collochi al di fuori del sistema del linguaggio stesso”. 108 Questo uso autoreferenziale del linguaggio si concretizza in una varietà di manifestazioni che vanno dalla devianza semantica alla formazione di neologismi, dai giochi di parole alle risposte per assonanze.
107
Già Wittgenstein ha evidenziato come l’uso delle definizioni ostensive, ovvero d ei termini meramente denotativi, oltre a conservare una certa ambiguità nella denotazione, risulti vacuo dal punto di vista semantico. 108 J. Cutting, I disturbi del linguaggio nella schizofrenia , in M.R.Monti-G.Stanghellini, Psicopatologia della schizofrenia, Milano, Raffaello Cortina, 1999, p.49 61
Una peculiarità linguistica della schizofrenia è la frequente presenza di neologismi. Lo schizofrenico, avvertendo l’insufficienza del vocabolario a disposizione, conia volontariamente nuovi termini, per riuscire ad esprimere una particolare situazione od esperienza che resterebbe altrimenti inesprimibile: “vengono formate intenzionalmente parole nuove per indicare sensazioni o cose per le quali il linguaggio non ha parole ”.109 I neologismi sono di solito formati dall’alterazione più o meno marcata di parole già esistenti; lo schizofrenico per coniare nuovi termini attua cioè una deviazione, o una distorsione, semantica. Il problema e il limite di questi neologismi è che sono caratterizzati da una simbologia personale ed esclusiva: il termine adottato dallo schizofrenico ha un carattere altamente privato, idiosincratico e spesso criptico, pertanto risulta incomprensibile agli altri. Il vocabolario comune racchiude il linguaggio di una presenza certa e salda, sicura di sé; ecco perché lo schizofrenico, vittima di una radicale crisi della presenza, avverte l’inadeguatezza e la insufficienza di questo vocabolario. Esperendo la labilità e la precarietà della propria identità e presenza, lo schizofrenico vive il suo essere immerso nel mondo in maniera diversa, la sua esperienza è altra ed ha pertanto bisogno di un altro linguaggio per poter essere espressa. È dal linguaggio infatti che scaturisce la
nostra esperienza del mondo, la nostra esperienza di noi nel mondo. “ Non secondariamente nel linguaggio, ma primariamente come linguaggio, appare nell’opera intellettuale una modificazione dell’individuo e della sua esperienza” 110. Ogni “tipo” di linguaggio caratterizza l’appartenenza ad una determinata forma di vita111; ogni diverso linguaggio “ha” cioè un diverso mondo, una diversa presenza sul suo sfondo. Linguaggio e presenza sono dunque profondamente collegati: l’atto linguistico germina da un individuo, scaturisce da un io, e attraverso di esso si manifesta l’essere ch’è dietro la persona.
109
K. Jaspers, Psicopatologia generale, 1913 K. Jaspers, Psicopatologia generale, 1913 111 In Wittgenstein la padronanza o meno di un “gioco linguistico” caratterizza l’appartenenza o meno ad una determinata forma di vita. 110
62
3.7 Dissociazione semantica
La devianza semantica indica lo spostamento del significato dal segno originale ad un nuovo aggregato fonetico (il neologismo appunto), ma vi sono casi in cui la devianza degenera in una vera e propria dissoluzione, o dissociazione, semantica. In queste circostanze la dimensione semantica viene completamente a saltare e l’attenzione del parlante patologico è rivolta esclusivamente all’aspetto fonico delle parole . La dimensione acustica diventa l’aspetto preponderante e in base al quale viene espletata la discorsività linguistica. Una ragazza schizofrenica afferma “mia madre mi fece una domanda cui risposi con una frase rimata che non aveva senso”
112
, o ancora
“non mi sforzavo di inventarle [le parole]; venivano spontaneamente e non significavano nulla per conto loro; erano il tono, il ritmo e la pronuncia che possedevano un senso”. 113 Nella dissociazione semantica la relazione semantica delle parole è attenuata fino ad essere persa: il segno è “fluttuante” e completamente autonomo in relazione al contesto comunicativo. Questo uso, che potrebbe definirsi ludico, del linguaggio esclude qualsiasi finalità comunicativa ed espressiva. Gli schizofrenici possono giocare con le parole combinandole tra di loro senza alcun interesse per il significato, ma basandosi esclusivamente su associazioni per assonanze. In questi casi i locutori patologici conferiscono al suono della parola maggiore importanza che al suo significato; il loro discorso procede cioè “sulle linee delle associazioni esterne anziché interne della presentazione della parola”.114 Un esempio classico riportato da Piro: “a me non piace la televisione, piacerebbe la tele ma non la visione, più la sione che la vi, perché la vi mi ricorda la lettera V che è nella TV che significa televisione e a me non piace”. 115 La dissociazione semantica comporta la totale perdita di intenzionalità comunicativa: al suono di una parola viene associato il significato di un’altra parola scelta per mera assonanza con la prima; vi è un
112
Tratto da P. Bertrando, Vivere la schizofrenia , Torino, Bollati Boringhieri, 1999 M.A.Sechehaye, Diario di una schizofrenica, Firenze, Giunti, 2000, p.93 114 Sigmund Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio , Roma, Newton Compton, 1976, p.127 115 Sergio Piro, Parole di follia. Storia di persone e linguaggi alla ricerca del senso e del significato nella schizofrenia , Milano, Franco Angeli, 1992, p.44 113
63
appiattimento del significato sul significante e una conseguente dissoluzione del livello semantico.
3.8 Linguaggio e presenza
La varietà di anomalie linguistiche, che abbiamo visto essere caratteristiche dello stato schizofrenico, non devono essere lette come un’esclusiva sintomatologica della specifica patologia; si tratta piuttosto di una serie manifestazioni che caratterizzano il piano linguistico di ogni presenza che stia esperendo una radicale crisi. Le alterazioni di semanticità presenti nello stato schizofrenico vanno cioè considerate come il genere di una specie, dove la specie è quella della crisi della presenza. Abbiamo visto come il neologismo serva a tradurre a parole dei vissuti ineffabili, delle esperienze altrimenti indicibili: quelle esperienze di crisi e di fine del mondo esperite da un soggetto sull’orlo del baratro; vissuti che non possono essere compresi da una presenza certa e garantita, e che non possono essere “detti” dal linguaggio “normale”, appartenente a questa salda presenza. Il neologismo dello psicotico dunque “non è un errore ma un bisogno di natura ontologica”116, è il prodotto linguistico di una presenza in crisi, che avverte il mondo mutato e che cerca di esprimere questo radicale mutamento di significato che la riguarda. Le alterazioni di semanticità, il suo eccesso o il suo difetto, coincidono con un’alterazione sul piano ontologico. Neologismo, paralogismo, giochi di parole e di assonanze significano l’impegno in un mondo diverso, in un mondo nuovo, poiché il mondo comune, il mondo di tutti non è più familiare, sta crollando. Il significato consueto non ha più un significante e il significante non trova più un significato univoco: vi è un “allargamento della trama di referenza”117, un aumento (o una contrazione) dell’alone semantico delle cose e degli eventi.
116
A. Pennisi, Psicopatologia del linguaggio, Roma, Carocci, 1998 S.Piro
117
64
La dissociazione semantica, l’eccesso e il difetto di semanticità costituiscono dunque reazioni -linguistiche così come ontologiche- di fronte alla perdita di un mondo familiare e domestico, di fronte ad un significato che si fa cosmico e catastrofico.
3.9 Wahnstimmung e intenzione di significato
Una presenza in crisi è una presenza alienata, cioè una presenza fuori-di-sé e che riporta necessariamente la sua alienazione nel rapportarsi al mondo. La crisi della presenza investe del carattere alienante e
“delirante” tutta la realtà percepita, tutte le
rappresentazioni e le esperienze vissute. Il termine “delirio” è legato all’esser -fuori-di-sé della presenza alienata; l’etimologia del termine (de-lira) ci riporta a questo “andare fuori”: la lira infatti era l’antico nome dell’aratro e il suffisso de esprime l’allontanamento, il movimento trasbordante, insomma la fuoriuscita dal solco dell’aratro 118. In tedesco “delirio” è dato dal termine “Wahn”119, derivante dall’antico “wahna”, che significa “vagare”. Lo psichiatra e filosofo tedesco Jaspers 120, per descrivere lo stato delirante della presenza in crisi, conia il termine Wahnstimmung , dove Stimmung può essere tradotto con “atmosfera”. Lo stato delirante della presenza, cioè il vissuto della Wahnstimmung , porta con sé una modificazione radicale della coscienza di significato: alle percezioni viene attribuito un significato abnorme, profondo, sovraccarico e intenso, spesso interpretato nel senso dell’autoriferimento. La percezione effettiva del mondo è la medesima, le impressioni quantitative e qualitative sono registrate esattamente, tuttavia niente è più lo stesso, tutto è diventato non domestico, spaesato ( unheimlich). Il mutamento, che ha l’esperiente per centro ( res tua agitur ), concerne il più banale accadere quotidiano; l’ambiente di tutti i giorni è cambiato, ma non dal punto di vista sensibile, (le percezioni sul piano sensoriale sono infatti rimaste immutate), si tratta
118
Dunque, letteralmente, delirio significa “andar fuori dal solco”. Eloquente il fatto che tutt’oggi, nel tedesco, si utilizzi questa parola sia per indicare il delirio che la follia. 120 Karl Jaspers (1883-1969), psichiatra e filosofo tedesco tra i maggior i esponenti dell’esistenzialismo. L’opera cui facciamo principalmente riferimento in quest’ambito è Allgemeine Psychopathologie (1913) 119
65
bensì di una “alterazione semantica”, di una modificazione di significato delle cose che dà luogo ad un’atmosfera incerta e oscura. La Wahnstimmung consiste in una “disposizione umorale di non -domesticità sinistra, nella quale si muove in modo occulto e inesprimibile una minaccia decisiva, totale”: 121 è l’esperienza di un mutamento oscuro e radicale che interviene nel percepire e nel percepito, e nella quale il soggetto si sente spaesato e perduto; ogni cosa acquista un nuovo significato, indefinito quanto minaccioso e inquietante. Le cose si mettono improvvisamente a significare qualcos altro, “c’è qualcosa” ma non si sa che-cosa. Oggetti ed eventi assumono un significato spropositato e angosciosamente indeterminato, vacuo e opprimentemente indefinito: la disposizione d’animo delirante non ha ancora trovato un determinato contenuto da tematizzare, il delirio non si è ancora concretizzato in qualcosa di definito, è delirio senza soggetto e senza oggetto. Gli oggetti che abitualmente occupano il nostro spazio quotidiano, permettendo che questo risulti riconoscibile e confermante la nostra identità, non risultano più utilizzabili in base alla rete di rimandi significativi che normalmente aprono; hanno perso il loro carattere strumentale ed operativo, la loro memoria di condotte possibili, la loro funzione di essere appunto un rimando, un “qualcosa per”, e di conseguenza hanno perso la loro utilizzabilità, la loro Zuhandenheit .122 Come suggerisce Bergson, la maniglia è tutt’uno con il significato dell’aprire la porta; una volta aperta la porta, essa cade nel buio, e, i n questo senso, non “significa” più, e anche “non c’è” più. Nella Wahnstimmung c’è l’intenzione, tuttavia, essa non è ancora intenzione-di, non è ancora intenzione di un soggetto, né intenzione di un oggetto; non è ancora intenzione piena né vuota ma “pura apertura alla Erfüllung , potenza indecisa della Bedeutung , dunque vuoto, Leere, che per essere pronto ad ogni significato non ne ha alcuno”. 123 Nella Wahnstimmung l’intenzione di significato non si compie, non si conclude, il mondo perde il suo carattere di utilizzabilità, si riduce a puro esistere cosale, privo di connessioni funzionali, “fluttuante”, privo di significato compiuto.
121
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., p.49 Termine heideggeriano che, alla lettera, può essere tradotto con “essere-alla-mano” riferito alle cose 123 F. Leoni, Senso e crisi. Appunti sulla “Fine del mondo” in Bruno Callieri ed Ernesto de Martino , p.90 122
66
‹‹ Nell’individuo che presenta una Wahnstimmung siamo sempre di fronte ad una coscienza di significato: potremmo dire che si tratta di una semplice “intenzione di significato” senza “compimento di significato”, e che, quindi, per questo sembra indeterminata, fluttuante vaga. […] è proprio in questa dif fusione abnorme, specificità e genericità dell’intenzione di significato che risiede la caratteristica strutturale più importante della Wahnstimmung . Ciò determina una trasformazione, una sfocatezza ed un capovolgimento del significato di tutto quel che ci circonda: l’esperienza del mondo si carica di rapporti potenziali multipli, contrastanti, equivoci. […] Nella Wahnstimmung tutto il percepito e il percepiendo ha perduto il suo significato abituale e
non ha ricevuto nessun altro significato che possa, sia pure transitoriamente, sostituirlo››.124
3.10 Eccesso e difetto di semanticità
Questa mutamento dell’esperienza di significato oscilla tra un “troppo” e un “troppo poco” di semanticità. Il mondo nasce e si mantiene grazie all’impegno di una presenza che gli conferisce un significato compiuto; il venir meno di questo conferimento porta al crollo del mondo: il mondo si avvia verso il finire perché si avvia verso il finire la presenza chiamata ad iniziarlo e a mantenerlo sempre di nuovo (“il firmamento croll a perché Atlante più non lo regge” 125). In questa crisi la presenza vive un’angoscia senza contenuto: l’angoscia per il suo stesso abdicare; quest’ansia, immensa quanto vuota, si carica di intenzioni di significato rivolte al mondo, intenzioni che vengono a poggiare su complementi di significato abnormi, quanto privati e tragicamente personali: ‹‹ Appunto perché è caduta in crisi la stessa potenza alterificante […] in tutte le cose del mondo si muovono intenzioni oscure, e questo è il segno che oscurata è l’unica intenzione capace di illuminare il mondo, l’intenzione umana, onde nelle oscure intenzioni delle cose si riflette in realtà la stessa possibilità di una decisione umana che cerca se stessa, l’alienazione radicale di questa possibilità››126.
124
Id., pp.91-92 E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali , cit., pp.58-59 126 Id.,p.152 125
67
Queste intenzioni di significato, prive dello sfondo di una salda presenza che le indirizzi e che le sorregga, non trovano la loro direzione, cioè il loro compimento, sfociando pertanto nell’eccesso o nel difetto di semanticità. ‹‹ Il significato oscilla allora intorno al (suo) nulla: into rno al nulla del suo senso. […] Il significato, l’esperienza del significato, è il mobile equilibrio tra intenzione di significato e compimento di significato. Nell’intenzione di aprire la porta, per riprendere l’esempio bergsoniano, mi si rivela il mondo nella prospettiva dell’aprire, e la maniglia come centro prospettico di quel mondo. Ecco la “presenza” concomitante, rispondente corrispondente, della mia mano che la afferra e della maniglia che è afferrata. Ecco il compimento del significato […]. Esperienza è il gioco ritmico del senso e del significato: del venire alla luce di un significato entro l’indeterminata (rispetto al significato stesso) potenzialità del senso […]. Ana strofe e catastrofe, dice anche, genialmente, De Martino […]. Anastrofe dell’esperienza dal senso al significato, in direzione cioè della cultura nel senso demartiniano; e catastrofe dell’esperienza come naufragio
del
significato
nel
senso,
di
cui
reca
traccia
il
crollo,
il
Weltuntergangserlebnis, la “nuda crisi”, l’esperienza pura››.127
Ciò che accade nel vissuto del mutamento, nell’esperienza della metamorfosi del significato è dunque l’acquisto, da parte del mondo, di un “troppo” o di un “troppo poco” di semanticità. Per un verso l’intenzionalità che non ha trovato il suo compimento vaga liberamente, in un vuoto oltre onniallusivo e minaccioso che travaglia ogni ambito percepito. In questo eccesso di semanticità l’universo è in tensione: gli ambiti percepiti partecipano a tutto il
reale e a tutto il possibile, senza sosta e senza mai offrire un appiglio operativo. Ogni percepito accenna disordinatamente a tutti gli altri; in cerca di semanticità si destruttura, annichilito nello stesso, e dallo stesso, penetrante alone semantico. Gli ambiti percepiti vanno cioè oltre in modo irrelato, caoticamente onniallusivi, carichi di una tensione verso un vuoto che minacciosamente, e sterilmente, allude-a tutto. Ogni cosa deborda dal suo ordine, gli oggetti fuoriescono dai loro limiti domestici, perdono la loro operabilità consueta e la loro memoria di condotte possibili per farsi indici di un oltre indeterminato e vacuo, “indici-di”, senza un termine di riferimento. 127
F. Leoni, Senso e crisi. Appunti sulla “Fin e del mondo” in Bruno Callieri ed Ernesto de Martino , cit., pp. 89-90 68
Nella vana ricerca del suo oltre ogni percepito, suscettibile di diventare qualsiasi cosa, si deforma mostruosamente, si disfà, dilaniato da una cieca forza in cerca di significato che lo spinge a trasformarsi perpetuamente in altro. Ogni percepito è pura potenza senza atto, e mai trova riposo in una percezione autentica e definita. Ogni percepito è un oltre, è possibilità, ma senza realtà, indeterminazione che non si determina, significante che non si curva in un significato, quodditas che non si fa quidditas, insomma potenza senza atto. L’eccesso di semanticità equivale dunque ad uno stato di potenzialità informe che, sul piano del linguaggio, si esprime in una progressiva indeterminazione della parola; il discorso, svincolato da riferimenti univoci, si carica di un’allusività plurima ed oscura. In questo universo teso nella ricerca di un significato, in questo eccesso di semanticità che dilaga, ma mai si risolve in significati determinati, la presenza cade vittima di un incontrollabile vortice inflazionistico: anziché oggettivare il mondo, e quindi “conquistarlo”, è il mondo che irrompe minacciosamente in essa, che la attraversa e che la invade. La presenza defluisce nel mondo, e il mondo la riassorbe nel suo caos, un caos informe perché soltanto potenziale. Il decorso opposto, il vissuto polare e antinomico rispetto a quello del “troppo” di semanticità, è quello del “troppo poco” di semanticità. Se nell’eccesso di semanticità l’intenzionalità di significato è una tracotanza che annulla ogni confine e vaga irrelata, nel difetto l’intenzionalità si sclerotizza, è passiva e assente: gli ambiti percettivi sono investiti da una tragica inerzia e, impartecipi di qualsiasi oltre che li collochi in un ordine, si fanno finti, rigidi, teatrali, artificiali. Il discorso è ridotto ad una serie delimitata di segnali monocordi, il segno regredisce a mero segnale, prevale la ripetizione coatta delle stesse formule e degli stessi gesti. Gli oggetti perdono corposità, si chiudono in se stessi, diventano “intoccabili”, fuori d’ogni intenzionalità e relazione possibile. Le cose si fanno inconsistenti, meccaniche e insignificanti, cadono dal quadro dei possibili progetti operativi: si perde cioè l’autentico oltre delle cose, il loro consueto orizzonte di operabilità e di progettabilità. Tutti gli ambiti sono immobili, irrigiditi, senza significato e senza oltre, senza uno sfondo che li renda esperibili. Ogni percepito è un irrelativo, un fuori posto isolato; il
69
mondo è lontano, perduto in un’alterità radicale e irraggiungibile, e la presenza è separata da esso, distaccata, senza alcuna possibilità di comunicazione significante. L’universo, che nel “troppo” di semanticità era in tensione, nel “troppo poco” di semanticità si fa sclerotico, rigido, cristallizzato, un universo di gomma, un universo già morto. La presenza si contrae, sprofonda in una sorta di “eterno presente”, il mondo rinsecchisce e si semplifica, non c’è oltre possibile: ci sono atti, ma non c’è potenza.
3.11 Troppo e troppo poco
Eccesso o difetto di semanticità, potenza senza atti, atti senza potenza: ecco i due speculari modi in cui si concretizza il demartiniano rischio della fine del mondo, in cui si dà a vedere la regressione del processo antropogenetico. Troppo o troppo poco di semanticità: ‹‹ o il mondo si allontana lasciando una intimità vuota, privatissima, incomunicabile, raggelata, sprofondata in una solitudine miserabile, oppure irrompe non lasciando margine per le più piccole possibilità di ripresa, di appropr iazione, di scelta valorizzante››.128 In entrambi i casi quello che si esper isce è il vissuto di un’alterità radicale: il mondo è mutato o, meglio, il mondo sta mutando. Entrambe le polarità, di tensione e di immobilità, di forza onniallusiva e di rigidezza, portano il segno dell’alienazione e dell’essere-agito-da. Ambedue i vissuti manifestano il “diventar altro” di ciò che sta alla radice dell’io e del mondo, ‹‹l’annientarsi della energia valorizzante della presenza, il non poter emergere come presenza al mondo e l’esperire la catastrofica demondanizzazione del mondo, il suo “finire”››. 129 Nell’eccesso e nel difetto di semanticità la mondanità diventa “radicalmente altra”, e tale mutamento è esperito come un’alterazione che ha un senso personalissimo: qui come non mai, tua res agitur : ‹‹alcunchè di radicale investe le radici stesse della persona, riguarda questa persona, allude perentoriamente ad essa››.130
128
E. de Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, cit., pp. 89-90 Id.,p. 631 130 Id.,p. 59 129
70
Alla ricerca di un significato la semanticità erra, carica di tutto e di nulla, e “schiaccia per questa sua estrema sovrabbondanza fatta di estrema miseria” .131 Nel mondo che diventa tutt’altro, nell’impossibilità di conferire un senso ed un significato, la presenza vive ‹‹il suo non poter oltrepassare il limite nel valore, vive il suo “morire”››. 132 Il catastrofico flettersi dell’energia relazionale e semantica fa sì che il morire di cui si patisce non è “indicabile”, ma si tratta di un morire che ha investito la stessa potenza chiamata a superare e ad oltrepassare i diversi “morire” storici, quella potenza che permette alla presenza di trapassare la situazione nel valore, e quindi di essere presenza; nonchè la medesima potenza in luogo della quale il mondo assume un significato, cioè è effettivamente mondo.
131
Id.,p. 631 Ibidem
132
71
BIBLIOGRAFIA
BERARDINI S.F, (2013), Ethos Presenza Storia. La ricerca filosofica di Ernesto de Martino, Università di Trento
BINSWANGER L., (1942), Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins ; trad. It. Essere nel mondo, Astrolabio, Roma, 1973 BRELICH A., (1988), Prolegomeni a una storia delle religioni , H. Ch. Puech (a cura di), in Religione e storia delle religioni , Roma-Bari CALLIERI B., (1955) Contributo allo studio psicopatologico dell ’esperienza schizofrenica della fine del mondo, in ‹‹Archivio di psicologia, neurologia e
psichiatria››, XVI CHERCHI P., (1994), Il signore del limite: tre variazioni critiche su Ernesto De Martino, Napoli, Liguori
CROCE B., (2010), Teoria e orizzonti , Ivan Pozzoni (a cura di), Limina Mentis CROCE B., (1949), Intorno al magismo come età storica , in ‹‹Filosofia e storiografia››, Bari DANTI D., (2007), Dalla presenza alla singolarità. Uno studio su Ernesto de Martino , tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa DE MARTINO E., (1941) Naturalismo e storicismo nell’etnologia, Laterza, Bari DE MARTINO E., (1943-1946), Adolfo Omodeo, in ‹‹ Studi e materiali di storia delle religioni››, XIX-XX DE MARTINO E., (1948), Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo , Einaudi, Torino
72
DE MARTINO E., (1953-1954), Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto , in ‹‹ Studi e materiali di storia delle religioni››, 24-25 DE MARTINO E., (1959), Sud e magia, Feltrinelli, Milano DE MARTINO E., (1962), Furore, simbolo, valore, Il Saggiatore, Milano DE MARTINO E., (1962) Magia e civiltà, Garzanti, Milano DE MARTINO E., (1964), Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche, in «Nuovi argomenti», 69-71 DE MARTINO E., (1977) La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Clara Gallini (a cura di), Einaudi, Torino
DE MARTINO E., (1993), Scritti minori su religione, marxismo e psicoanalisi , Roberto Altamura e Patrizia Ferretti (a cura di), Nuove edizioni romane, Roma DE MARTINO E., (1995), Storia e metastoria: i fondamenti di una teoria del sacro , M. Massenzio (a cura di), Argo, Lecce DE MARTINO E., (1998), Ernesto De Martino nella cultura europea, C. Gallini, M. Massenzio (a cura di), Liguori, Napoli DE MARTINO E., (2005), De Martino: Occidente e alterità , M. Massenzio, A. Alessandri (a cura di), Biblink editori, Roma, 2005 DE MARTINO L., (1997), Rituali della memoria. Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche, Argo
DURKHEIM. E, (1912), Les formes élémentaires de la vie religieuse; trad.It. Le forme elementari della vita religiosa , Milano, 1963
ELIADE M., (1968), Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétitions , Paris, 1949; trad. It. Il mito dell’eterno ritorno, Roma FRAZER J.G.,(1922), The Golden Bough. A study in Magic and Religion , London,; trad.It. Il ramo d’oro, Torino, 1990 73
FREUD S., (1905), Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten ,; trad.It. Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio , Newton Compton, Roma, 1976
FRITH C., (1996), Neuropsicologia cognitiva della schizofrenia , Cortina Raffello HEIDEGGER M., (1927), Sein und Zeit , Tubingen; trad.It. Essere e tempo, Mondadori, 2011 JAKOBSON R., (1963), Essais de linguistique générale ; trad.It. Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, 2008
JASPERS K., (1913,) Allgemeine Psychopatologie ; trad.It. Psicopatologia generale , Il Pensiero Scientifico, 2000 KANT I., (1781), Kritik der reinen Vernunft ; trad.It. Critica della ragione pura , Adelphi, 1995 LAING R.D., (1959), The Divided Self ; trad.It. L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale, Einaudi, 2001
LANTERNARI V., (1997), La mia alleanza con Ernesto De Martino e altri saggi postdemartiniani, Napoli
LEVY-BRUHL L., (1923), La mentalité primitive ; trad.It. La mentalità primitiva, Torino, 1975 MARRAFFA M., DE CARO M. (a cura di), (2013), La filosofia di Ernesto de Martino , in ‹‹Paradigmi›› , XXI, n.2 MASSENZO M., FILORAMO G., SCARPI P., RAVERI M., (2009), Manuale di storia delle religioni, Laterza, Bari
MAUSS M., (1903), L’esquisse d’une théorie générale de la magie; trad.It Teoria generale della magia , Einaudi, 2000
74
OTTO R., (1917), Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen ; trad.It. Il sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e la sua relazione al razionale , Milano, 1984
PETTAZONI R., (1960), Gli ultimi appunti, a cura di A. Brelich, in ‹‹Studi e materiali di storia delle religioni”, n.31 PIRO S., (1992), Parole di follia, Franco Angeli, Milano SARTRE J.P., (1938), La nausée; trad.It La nausea, Einaudi, 2005 SASSO G.,(2001), Ernesto De Martino fra religione e filosofia , Bibliopolis, Napoli SAUSSURE F., (1916), Cours de linguistique générale ; trad.It Corso di linguistica generale, Laterza, Bari, 1978
VAN DER LEEUW G., (1933), Phänomenologie der Religion ; trad.It. Fenomenologia della religione, Torino, 1992
VIRNO P., (2003), Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana , Bollati Boringhieri WITTGENSTEIN L., (1953), Philosophische Untersuchungen; trad.It. Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 2009
ZANARDI C., (2011), Sul filo della presenza. Ernesto De Martino fra filosofia e antropologia, Unicopli edizioni
SITOGRAFIA
Cherchi G., Ernesto de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Giornale critico di storia delle idee,
http://www.giornalecritico.it/Biblioteca/biblio-GianpaoloCherchi-deMartinoMondomagico.htm
75